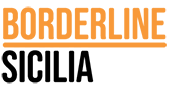Costruirsi un futuro nell’attesa infinita: voci di migranti nei centri di prima accoglienza di Vittoria
Lo stato di perenne e continua emergenza si traduce in lunghissimi e vuoti tempi di attesa per moltissimi migranti. Nei centri di prima accoglienza (CAS) si rimane ben oltre il tempo minimo per iniziare la procedura della richiesta d’asilo. I migranti ci restano per mesi, trimestri e anche semestri, spesso con poco più di un posto letto e di pasti garantiti, con il pensiero fisso sui primi documenti e sulle prime possibilità di autonomia nel luogo di approdo. E così, chi ha rischiato la vita per sopravvivere, si trova ad elaborare nuove strategie per costruirsi quel futuro che ha cercato con determinazione. Nel frastuono dei media e dei luoghi comuni, non è facile pensare a come può o dovrebbe essere strutturata l’accoglienza data ai profughi, oltre a vitto ed alloggio, come se queste persone fossero poco più che numeri e corpi indesiderati, con cui confrontarsi solo sulla base delle banali esigenze primarie. Fortunatamente alcune occasioni di incontro creano sprazzi di consapevolezza e portano alla luce le persone e le diversità che stanno dietro ai conteggi organizzativi.
E’ quello che ci dicono anche i ragazzi di alcuni CAS di Vittoria, che andiamo a visitare in uno splendido pomeriggio di dicembre, i quali ci descrivono le fatiche e le soddisfazioni quotidiane del fare rete coi cittadini del posto. Ci rechiamo inizialmente in due dei quattro centri di prima accoglienza gestiti dalla Cooperativa Sociale Area, attiva da quasi un anno nell’accoglienza dei migranti nell’area del vittoriese. Per primi conosciamo i 7 migranti trasferiti dalla struttura di prima accoglienza di Scoglitti, chiusa di recente, ed ora alloggiati stabilmente in un appartamento nel centro città. Nella casa convivono migranti provenienti da Senegal, Gambia, Nigeria e Libia, sbarcati a Pozzallo il 30 ottobre scorso, per lo più in attesa di formalizzare la richiesta di protezione internazionale. Dei sei ragazzi presenti, inizialmente solo uno ci presta attenzione, iniziando ad elogiare in un perfetto francese le condizioni di vita in Italia: “Sono felice di stare qui. Sto bene e sono fortunato”, ripete C. , mentre altri ragazzi siedono inespressivi davanti al televisore. La situazione cambia repentinamente all’arrivo di R., ormai designato come l’interprete del gruppo. “Quando ho saputo della visita sono stato contattato dall’operatrice e corso qui. So bene che il mio ruolo di traduttore è fondamentale per la convivenza di questo gruppo. Senza di me sarebbe impossibile una mediazione tra francofoni, anglofoni e ragazzi che parlano solo bambara’nell’appartamento.” Effettivamente R. consente a tutti i presenti di inserirsi nella conversazione, ed ecco che lentamente conosciamo la voce e le storie di M., fuggito solo pochi mesi fa dalla Nigeria e scampato a due attentati, di G., proveniente dal Gambia e dello stesso R., che parla ben nove lingue ed ora passa le sue giornate tra questa casa e il centro Sprar gestito dalla comunità valdese a Vittoria, dove può connettersi ad internet e soprattutto conoscere altri ragazzi africani. “Io qui vivo da migrante. Che non significa sopravvivere ma essere consapevoli della fatica necessaria per conquistarsi la fiducia della gente e garantirsi un tenore di vita decente. So di partire svantaggiato ma conosco pure le mie risorse, e tra queste c’è la fiducia nella solidarietà umana. Credo che conoscere più persone e realtà sia il modo migliore per integrarsi in una società, come sta succedendo a me in questa piccola cittadina”. All’opposto di R., un altro ragazzo gambiano ci confida la sua sfiducia totale nelle istituzioni italiane, per quanto riguarda l’arrivo dei documenti e la possibilità di imparare la lingua e trovare lavoro: “ Io non esco mai dal centro perché ho paura. Non ho ancora i documenti e non so cosa potrebbe succedermi se mi fermasse la polizia”. Percorsi e pensieri diversi, viziati probabilmente anche dalle poco chiare informazioni che giungono ai ragazzi e a cui si deve rimediare. Il tempo passa e arriva in ultimo M., cittadino libico, accompagnato da un amico tunisino, a quanto pare molto attivo nella moschea di questa zona. “Sono stato a lavorare nelle serre” dice M. “per fortuna in questo modo guadagno qualcosa e rimango attivo. Il lavoro fa sempre bene, si sa.”Cosa che non condividiamo assolutamente, pensando al sistema di sfruttamento del caporalato. Ma M. prosegue nel racconto della sua storia come per giustificare e dare spessore al suo percorso: “Nella mia vita ho sempre lavorato, soprattutto come muratore. Ma negli ultimi mesi stare in Libia era impossibile. Come tanti ho rimpianto spesso il periodo in cui c’era Gheddafi, e questo la dice lunga. Per punizioni, sviste e vendette si passano mesi in prigione, e questi sono i segni che mi ha lasciato il carcere”,dice mostrandoci diverse cicatrici che percorrono la schiena e le braccia, “ora che sono arrivato qui io voglio solo lavorare perché so che altrimenti impazzisco e che solo lavorando avrò qualcosa. Non posso aspettare, per questo aver incontrato amici alla moschea che mi hanno aiutato in questa ricerca è stato per me fondamentale”. Sogni, speranze e apertura verso una società che non accoglie certo a braccia aperte, ma pure disperazione e ansia costellano le loro giornate infinite. In molti danno l’impressione di essere in balia di se stessi, senza appoggi nel processo di integrazione nel mondo esterno, se non le saltuarie lezioni di italiano fornite dal centro.
Nel secondo CAS, situato presso l’abitazione signorile di un privato che l’ha concessa in affitto, conosciamo ben 10 ragazzi. “Loro sono arrivati ad inizio ottobre e sono più avanti nella procedura. Alcuni hanno addirittura già avuto l’audizione in Commissione” ci spiega l’operatrice. L’atmosfera che troviamo a Villa Alba, questo il nome della struttura, è decisamente più vivace, con un gruppo di migranti impegnati in una lunga conversazione mentre altri si aggirano indaffarati a sistemare la stanza o preparare la cena. Anche qui la lingua veicolare è il francese, essendo quasi tutti di nazionalità gambiana o senegalese, ma un portavoce dirige ad un certo punto la conversazione, diventata sempre più concitata dopo le prime presentazioni. “Oggi F. è stato in Commissione,”ci spiega, “ma non è molto soddisfatto. E’ come se certe cose fossero impossibili da esprimere, e infatti come raccontare in pochi minuti il terrore che spinge alla fuga?Credo sia per questa difficoltà che molti di noi si accontentano di un semplice permesso per lavorare. Alla fine ciò che conta è avere un documento, e da lì si può costruire un futuro.” Lo stesso pensa A., decisamente il più anziano del gruppo: “Io sono fuggito per salvarmi la pelle e qui non chiedo altro che poter lavorare. E non solo: ho anche un sacco di idee su come poter passare meglio anche il mio tempo libero e vivere questa città, visto che in Italia io voglio restarci”. Su questo punto anche gli altri ragazzi sembrano avere molto da dire: “Sai, questo paese non è piccolo, e ci sono un sacco di cose da fare. A Natale per esempio saremo tutti ospiti da amici volontari che ci offriranno una cena. E una volta a posto con i documenti, mi piacerebbe poter riprendere a giocare a calcio, organizzare una squadra o un torneo, insomma: vivere da uomo libero” dice C.
C’è chi invece a calcio gioca ogni giorno, ma non vede l’ora di andarsene da Vittoria e raggiungere una grande città. Incontro M. per la strada, la settimana successiva, dopo esserci dati appuntamento per telefono. M. sta da quattro mesi in un altro CAS vittoriese, molto lontano dal centro città, dove l’ho conosciuto all’inizio del mese di ottobre. In quell’occasione mi aveva narrato la sua fuga, dalla Sierra Leone al Gambia, dove lavorava come capo guardia in un campo di addestramento per giovani soldati, per potersi pagare gli studi e mandare qualcosa alla famiglia che non poteva lasciare il paese. Ma anche qui, per evitare un reclutamento forzato, l’unica via è stata una nuova fuga: Senegal, Burkina e infine Libia, dove la possibilità di lavorare nel settore edile c’era, ma in condizioni di schiavitù: “I capi ci venivano a prendere la mattina e ci riportavano nel nostro rifugio la sera, rifornendoci di cibo.Se avessero visto dei neri per strada facilmente saremmo stati assaliti da ladri o bande criminali” ricorda M. Il soggiorno in Libia si è quindi trasformato nel preludio all’ennesimo viaggio, questa volta verso l’Italia, dove una volta arrivato M. si è dichiarato minorenne, ascoltando i consigli di alcuni compagni, per la paura di non avere documenti e soprattutto essere rimpatriato. Solo grazie ad un colloquio con un operatrice M. cambia poi la sua idea e dichiara la vera età, rimanendo tutt’oggi comunque in uno stato d’ansia totale “Ho paura, tantissima paura di non poter avere i documenti. O di averli sbagliati per via delle prime dichiarazioni. Ma io non sapevo nulla della legge e non posso permettermi di rischiare il rimpatrio. Mi ucciderebbero.” Ancora oggi M. non chiama nessun amico o parente per il timore di metterli a rischio. Intanto cerca di non disperarsi, aspetta la chiamata in Commissione e cerca di imparare l’italiano. “Alla fine chi impara meglio l’italiano è chi lavora. Pure io ho lavorato per alcune settimane: dalle 5 del mattino alle 5 di sera nelle serre a raccogliere broccoli e pomodori. Alla fine però ho smesso, semplicemente perché spesso a fine settimana non mi pagavano nemmeno i 10/15 euro al giorno promessi. E io non ho mai potuto dire nulla, perché sono senza documenti.” Tentare di costruirsi un futuro, in un paese dove chi non ha voce è troppo solo e facile preda di ogni tipo di sfruttamento, e la lista d’attesa per il riconoscimento dei propri diritti può durare anche mesi o addirittura anni. Sempre più spesso viene da chiedersi con quale coraggio si possa parlare di accoglienza e integrazione.
Lucia Borghi
Borderline Sicilia Onlus