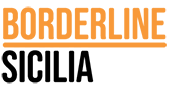Salinagrande: venti richiedenti asilo in una casupola con tetto in amianto.
Donna al settimo mese di gravidanza mai visitata. I racconti delle violenze nel C.I.E. di Milo
Quando arriviamo di fronte al C.A.R.A. di Salinagrande, poco dopo l’una, i cancelli sono chiusi e i dintorni deserti. All’interno del Centro per richiedenti asilo si scorge invece un certo movimento di operatori e forze dell’ordine. Sono pochi i migranti nel cortile interno, probabilmente sono ancora a mensa. Basta qualche minuto ed attiriamo l’attenzione di alcuni di loro, due tunisini piuttosto giovani, che chiedono alla guardia di poter uscire. Vogliono sapere se siamo venute per cercare manodopera. “Lavoro? Lavoro?” ci chiedono. Rispondiamo che siamo un’associazione di Palermo e che ci troviamo a Trapani per raccogliere testimonianze sulle condizioni di vita all’interno del C.A.R.A. Subito, ansiosi, iniziano a raccontare. Ma poiché abbiamo difficoltà a comunicare in francese due di loro tornano nel Centro e ci portano un amico che parla bene italiano, per farci da interprete. Il nostro traduttore ha ottenuto un permesso di protezione straordinaria della durata di un anno, è riuscito anche a trovare un lavoro, ma in nero. Non ha un posto dove abitare, così, insieme ad una ventina di richiedenti asilo, dorme in un edificio abbandonato in campagna, non molto distante dal C.A.R.A. Anche lì, ci dice, c’è poco spazio e chi non trova posto si arrangia dove capita; è stato anche nei C.I.E, al Vulpitta, a Chinisia, e a Milo, ed è in Italia per la seconda volta. La vita che tuttora conduce è difficile, ma nonostante tutto si sente uno fortunato, perché lui è sopravvissuto. Ci racconta l’esperienza nei C.I.E. Ci descrive il Vulpitta come un edificio molto vecchio e malandato, con servizi igienici in pessime condizioni, dice di aver patito il freddo e spesso anche la mancanza d’acqua. Viveva in una stanza molto piccola e affollata, ma il personale del centro lo trattava in maniera umana. Peggio nella tendopoli di Chinisia, dove è stato per pochissimo tempo; ci descrive le dure condizioni del campo: caldo asfissiante nelle tende, poca acqua, nessuna informazione, né ascolto. Ma l’esperienza peggiore l’ha vissuta a Milo. Lì le condizioni erano terribili, la polizia violenta e repressiva, li minacciava e li aggrediva, più volte, senza ragione. I migranti erano terrorizzati ed in stato di soggezione.
Interviene un giovane tunisino, ha compiuto diciotto anni da pochi mesi, è arrivato in Italia da un anno, ancora minorenne, dopo una traversata terribile durata cinque giorni. La sua imbarcazione, andata in avaria dopo dieci ore di viaggio, è rimasta infatti alla deriva, senza soccorso, per giorni. Dopo lo sbarco a Lampedusa è stato condotto in una casa famiglia dove si è trovato bene. Adesso ha ottenuto un permesso temporaneo di un anno, ma ha paura. Per il momento è ospite del C.A.R.A. con altri suoi coetanei. Vorrebbe studiare, lavorare e rimanere in Italia, ma teme che una volta scaduto il permesso di soggiorno lo riporteranno nel C.I.E. di Milo. Molti dei ragazzi con cui è arrivato, ci dice, sono stati a Milo e poi sono stati rimpatriati in Tunisia. Ci dice che i loro racconti sono terribili: pessime condizioni di vita e soprattutto ripetuti pestaggi. Non vorrebbero per nulla tornare in Italia, il nostro paese li ha terrorizzati, nonostante scappassero dalla dittatura di Ben Ali. Lui ricorda che durante il viaggio pensava di non farcela, che non sarebbe mai arrivato, ma rispetto a Milo persino la traversata perde di drammaticità. L’idea di tornare nel C.I.E. lo angoscia.
Quando si parla di Milo gli animi si esagitano La voglia di questi ragazzi di raccontare la propria esperienza è tangibile. Un altro giovane che segue la conversazione chiede al traduttore di raccontarci la sua. Anche lui è stato a Milo, che definisce un inferno. L’unico modo per ottenere qualche ora di pace è tentare il suicidio, per essere portato in infermeria e parlare con lo psicologo. Lo hanno fatto in molti. Tutti i ragazzi con cui parliamo confermano.
Si avvicina una donna, nel gruppo ce ne sono tre, parla solo arabo, così il nostro traduttore continua a farci da interprete. É al settimo mese di gravidanza, ospite del C.A.R.A. Si lamenta del cibo, che definisce avariato, e di non avere vestiti adatti, soffre il freddo, il caldo, a secondo del tempo. Teme per la salute del bimbo che porta in grembo, anche perché ha accusato dolori, e riferisce che nessuno l’ha mai visitata né le sarebbe mai stata fatta un’ecografia. É arrivata da quasi un anno col marito, volevano che il bambino nascesse in Italia e che diventasse italiano. Le spieghiamo che non è così semplice, perché attualmente la legge italiana è basata sullo ius sanguinis, ma lei ci esprime con speranza la convinzione che le cose cambieranno. Vorrebbe poter tornare per qualche giorno in Tunisia, per rivedere i genitori, ma non ha i soldi necessari.
La gente continua ad arrivare. Si sono formati due vivaci crocchi, vogliono tutti parlare con noi. Un ragazzo insiste particolarmente, i suoi amici ci avvisano che non sta bene. Parla poco ma riesce a farsi capire, anche grazie agli amici. É arrivato da un anno, ha fatto richiesta di asilo in Italia e poi si è diretto in Germania alla ricerca di un lavoro, ma senza successo. Il viaggio di ritorno è stato lungo e problematico, per mancanza di soldi; più volte ha dovuto fermarsi alla ricerca di lavoretti, così, quando è tornato al C.A.R.A. ha scoperto che la data della sua audizione in Commissione era già passata. Si è rivolto ad un avvocato per richiedere un’altra data, ma la sua richiesta di riesame non è stata accetta, ed adesso, come gli altri, ha paura di finire a Milo. Sta male, ma a suo dire dentro il Centro manca l’assistenza psicologica; questo problema non riguarda solo lui.
Interviene un ragazzo tunisino, molto giovane, non vive al C.A.R.A., anche lui dorme nell’edificio abbandonato vicino al Centro, e si arrangia come può per mangiare e lavarsi. Ci dice di stare male, che ha “tanto male alla testa”. Gli chiediamo se il problema riguarda gli occhiali che porta, ci risponde che non sono suoi, un suo amico li ha trovati e glieli ha regalati. In effetti non ci vede bene e non ha soldi per comprare gli occhiali. Ma non è per questo che sta male: vorrebbe spiegarsi ma si confonde e riprende a parlare in arabo. Un suo amico ci spiega che ha problemi mentali e dovrebbe prendere delle medicine. “A Milo sanno tutto, è da lì che viene” ci dicono. Lo hanno semplicemente rilasciato e indirizzato al C.A.R.A. “ma nessuno lo ha aiutato”.
Si ferma, incuriosito, anche un giovane del Togo, in bicicletta. Non vive all’interno del C.A.R.A. ma è ospite a Trapani, assieme ad altri tre migranti, della cooperativa Badia Nuova, la stessa che gestisce il C.A.R.A. di Salinagrande ed il C.I.E. di Milo. Dice di trovarsi abbastanza bene, ma che il suo problema più grosso è riuscire a trovare lavoro. Infatti pur essendo un richiedente asilo, ricorrente avverso il diniego della Commissione territoriale, ha un permesso di lavoro. Parla molto poco italiano, comunichiamo in inglese, gli chiediamo che lavoro svolgeva nel suo paese. È carrozziere, dice di essere in Italia da nove mesi. È fuggito dal suo paese a causa degli scontri tra cristiani e musulmani; era stato preso di mira in quanto assistente dell’Imam. Come molti aveva trovato lavoro in Libia ed è rimasto lì per otto mesi, ma è stato costretto a fuggire in seguito allo scoppio della guerra ed alle persecuzioni nei confronti dei sub-sahariani.
Avevamo appuntamento di fronte al Centro con uno dei pachistani incontrati la settimana precedente, un richiedente asilo che, come altri, non ha trovato posto al C.A.R.A. e vive da quattro mesi all’addiaccio, assolutamente privo della più elementare assistenza e di ogni mezzo di sostentamento. Si rifugia con altre tre o quattro persone in una casetta dell’A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autostrade e Strade) vicino ai binari ferroviari; mangia qualcosa grazie ad un amico ospite del Centro, che divide i suoi pasti con lui. È andato a farsi visitare al pronto soccorso del locale ospedale, come gli avevamo suggerito, dal momento che lamentava dolori e ci riferiva una già nota patologia renale, ma non aveva assolutamente idea di aver diritto all’assistenza sanitaria pubblica. Ci ha mostrato il referto medico e le prescrizioni terapeutiche che ovviamente sono in italiano e non gli sono state tradotte; lo facciamo noi. La diagnosi di calcoli renali con qualche complicanza comporta l’indicazione medica di bere molta acqua, di cui ovviamente non può disporre, come non dispone dei soldi per acquistare le medicine prescrittegli, per le quali lo indirizziamo al locale centro Caritas, o in alternativa ad Emergency.
Ha accompagnato da noi due afghani che dormono alle volte con lui nel minuscolo locale occupato lungo le rotaie, anch’essi richiedenti asilo non ospiti del C.A.R.A. ed assolutamente privi di assistenza. Ci raccontano di essere arrivati in Italia, a Bari, circa quattro mesi e mezzo fa. Per loro l’audizione in Commissione Territoriale è fissata a maggio ed anche loro non beneficiano di alcuna assistenza o mezzo di sostentamento, se non della solidarietà di qualche connazionale del C.A.R.A. disposto a condividere il magro pasto. Hanno presentato richiesta di asilo a Trapani, ma quando per la prima volta si sono recati in Questura sono stati condotti nel C.I.E. di Milo, che definiscono una prigione, dove sono rimasti tre giorni, prima di essere rilasciati ed indirizzati al C.A.R.A. di Salinagrande. Sono di fatto lasciati a sé stessi.
Con loro ci sono altri due afghani, ospitati nel Centro. Uno dei due ci racconta di essere arrivato a Bari come gli altri in autunno, ma da solo, a bordo di un container che è stato imbarcato in Grecia, a Patra. Ha pagato quattrocento euro ad un greco per viaggiare quattordici ore al buio, senza cibo né acqua. Ci spiega che per arrivare dall’Afghanistan in Europa i referenti da pagare sono normalmente due, uno dei quali in patria. Anche lui sarà ascoltato dalla Commissione solo a luglio, perché al momento non è disponibile un interprete della sua lingua, il Pashto . Entrambi si lamentano del cibo (solo pasta, niente carne halal) e della scarsa assistenza medica. L’acqua per lavarsi inoltre è fredda. Un tunisino ci spiega che per riscaldarla la raccolgono in bidoni che espongono ai raggi del sole. Nel cortile vediamo giocare un papà con tre bambini molto piccoli. L’acqua è fredda anche per loro.
Arrivano altri ragazzi, vorrebbero parlare con noi, ma dobbiamo andare. Prendiamo appuntamento per un’altra data. Ci dicono di essere contenti del nostro arrivo, anche se non abbiamo accesso al Centro. Riferiscono del clima oppressivo che respirano nel territorio. Anche quando sono in giro, nella loro quotidianità, fuori dalla struttura, si sentono controllati. Ma non dalla polizia, come ipotizziamo, bensì da locali che definiscono “mafiosi”. In molti annuiscono, “mafia dentro e fuori” aggiungono due ragazzi.
Prima di andare via, passiamo rapidamente in auto davanti alla baracca occupata dai richiedenti asilo: è fatiscente, e il tetto è in amianto, evidentemente lesionato.
Giorgia Listì e Valentina Caviglia