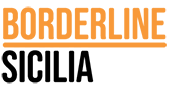L’accoglienza che conviene a pochi. Visita al Centro di Prima Accoglienza per minori di Castiglione di Sicilia
“Stato di emergenza”, “misure eccezionali”, “provvedimenti straordinari”: parole che spesso sono associate a prassi illegittime e fuori da ogni controllo ma che sembrano essere le uniche a guidare da anni il cosiddetto sistema di accoglienza italiano. Ne sono un esempio i CAS, centri di accoglienza straordinaria, e i centri di prima accoglienza che rientrano ormai da anni nella ”ordinarietà” del sistema di recezione dei migranti, per i quali scompare sempre più la possibilità di un accompagnamento da parte di figure professionali nella procedura di ottenimento dei documenti e nell’inserimento all’interno della comunità di approdo.
Da mesi diverse Prefetture, a seguito dell’ennesimo intervento legislativo dettato dall’emergenza, hanno autorizzato l’apertura di CAS e centri di prima accoglienza anche per minori non accompagnati, segnando un’altra botta di arresto alla possibilità di garantire una maggior tutela a questi soggetti, e implementando “l’accoglienza per grandi numeri“. Occasione ghiotta per molti enti gestori senza scrupoli che in Sicilia, come altrove, trovano nuovo terreno fertile per i propri affari. Da fine giugno vediamo il moltiplicarsi di queste strutture in ogni provincia e attualmente esiste già un problema di sovraffollamento per quelle esistenti. Le persone dovrebbero rimanervi per il tempo necessario all’identificazione ed all’avvio della procedura, i servizi previsti sono quelli di un assistenza minima di base e i numeri altissimi, ma di fatto questi centri vanno a sostituire spesso quelli di seconda accoglienza e la loro bassa qualità compromette fortemente il futuro percorso dei migranti in Italia. Una di queste è il centro di prima accoglienza per minori “La casa del migrante”, situato nella frazione di Verzella, che dista circa 7 km dal comune di Castiglione di Sicilia, un paese di poco più di tremila abitanti incastonato fra i boschi tra l’Etna e l’Alcantara e decisamente difficile da raggiungere senza un mezzo proprio.
Veniamo a conoscenza dell’esistenza della struttura parlando con alcuni migranti di passaggio a Catania: “Un mio amico è stato trasferito in un posto lontanissimo dove fa molto freddo. Forse non è nemmeno in Sicilia”. Ci mettiamo in contatto con il ragazzo che lamenta subito la mancanza di scarpe e vestiti, e l’isolamento forzato a cui è costretto: “Sono arrivato da due settimane e ho ancora solo le ciabatte di plastica. Siamo lontanissimi da tutto, anche da un negozio”. Il ragazzo ci dice di abitare con una quarantina di altri migranti uomini e tre ragazze nigeriane, rimaste dopo che altre tre loro compagne si sono date alla fuga, “da qui tutti vogliamo scappare, ma siamo così isolati che non possiamo fare nemmeno quello”.
Ci manteniamo in contatto con lui e dopo alcune settimane riusciamo a recarci presso la struttura, previo accordo con il responsabile di uno dei due enti gestori che scopriamo essere la Cooperativa Azione Sociale, già operante anche in diversi altri CAS nella provincia di Ragusa ed ente gestore dell’hotspot di Pozzallo fino a luglio 2016, e la Cooperativa Ippocrate di Enna. Lo stabile si sviluppa su due edifici, uno molto grande ed un altro nucleo più piccolo, in una struttura precedentemente destinata alla degenza di anziani, di cui ancora si ravvisano diverse tracce nell’arredamento interno e nel cartello posto all’ingresso. Ci presentiamo subito alle due operatrici in turno che ci fanno una fotografia della situazione. Il centro ha aperto nel mese di settembre, ospitando dapprima sei ragazze minori provenienti dalla Nigeria e poi accogliendo progressivamente solo maschi. Tre delle ragazze si sono allontanate spontaneamente ed ora i minori presenti sono ben 57, più le tre donne rimaste, con gli ultimi dieci ragazzi arrivati proprio il giorno precedente la nostra visita dal porto di Catania. Nei mesi si sono succeduti migranti provenienti direttamente dagli sbarchi, tranne un minore trasferito da un altro centro per decisioni di cui non riescono a darci una spiegazione, che è l’unico ad avere un tutore finora. Le nazionalità sono svariate: Nigeria, Gambia, Senegal, Mali, Ghana, Guinea Conakry, Costa d’Avorio, Eritrea e Somalia.
Alcuni ragazzi eritrei e somali sono stati inseriti in un programma “speciale”, di cui non ci è stato possibile capire niente di più che un loro trasferimento a Palermo, mentre gli allontanamenti spontanei sembrano essersi fermati negli ultimi tempi. Lo staff è composto da una decina di operatori, tra cui una psicologa, dei guardiani notturni e un mediatore. Sono state attivate collaborazioni esterne con un assistente sociale ed un legale. Ci riferiscono che all’arrivo ognuno viene fornito di un kit igienico, un cambio di vestiti, un paio di ciabatte e delle scarpe “che ci sono”, questione che avremo modo poi di discutere e verificare a lungo nel corso della nostra visita. Una volta al mese viene erogato il pocket money e delle tessere telefoniche; alcune volte sono state proposte lezioni di alfabetizzazione ed ultimamente sono stati presi contatti con una scuola locale per lezioni di italiano. Le operatrici dicono che i ragazzi non hanno particolari problemi di salute e a gruppi vengono sottoposti a screening medici presso un ambulatorio di Catania, occasione colta da alcuni come possibilità di fuga, soprattutto mesi fa.
Per tutti è stata avviata la procedura di richiesta del tutore anche se ci confidano che all’inizio è stato molto difficile per loro comprendere la procedura, perché non erano al corrente delle importanti e sostanziali differenze esistenti tra la prassi prevista per gli adulti e quella per i minori. Fatto decisamente grave per il quale consigliamo di confrontarsi immediatamente con il consulente legale, dopo aver accennato all’urgenza della questione per un’adeguata presa in carico. Chiediamo spiegazioni anche della presenza delle ragazze e della gestione della loro situazione all’interno del centro; sembra che mesi fa gli operatori di un’organizzazione, che su nostro suggerimento viene identificata come l’OIM, abbiano avuto dei colloqui con loro e parlato di possibili inserimenti in programmi di protezione particolari. Ad oggi per le ragazze non viene applicata nessuna misura di tutela speciale se non un limite alla ricezione di telefonate, sul cellulare che la struttura mette al servizio dei ragazzi, quando ci sono chiamate molto frequenti da certi numeri ricorrenti. Parliamo dei potenziali rischi derivanti anche da questa situazione e suggeriamo l’adozione immediata di provvedimenti adeguati, anche se ci viene continuamente ripetuto che le ragazze, arrivate a settembre, sono in fase di trasferimento. A detta delle operatrici, nessun altra organizzazione sembra aver visitato il centro dal momento della sua apertura.
Usciamo dall’ufficio per visitare gli altri spazi della struttura mentre un gruppo di ragazzi reclama insistentemente l’attenzione delle operatrici: durante il nostro colloquio abbiamo proposto più volte di fermarci per dare ascolto ai minori ma questo momento viene continuamente rimandato. Tra di loro, per la maggior parte in ciabatte di plastica o infradito, ci sono alcuni che dicono di essere arrivati stanotte e non aver ancora ricevuto nulla, ma anche loro vengono fatti attendere nonostante sottolineiamo l’urgenza della situazione. Visitiamo quindi velocemente le stanze dei ragazzi, situate nel corpo centrale dell’edificio: in ognuna quattro o cinque letti da ospedale e un bagno. Molti sono coricati, alcuni vagano per il corridoio bagnato arrabbiandosi per la mancanza di pulizia. C’è un soggiorno con Tv, una sala mensa ed un grande terrazzo, mentre le ragazze abitano in un piccolo edificio isolato. In tutti gli ambienti fa decisamente freddo.
Finalmente raggiungiamo i minori che da quasi un’ora attendono davanti all’ufficio reclamando ciabatte e vestiti. Sono circa una ventina e parlano tutti francese, motivo per cui ci troviamo ad interloquire con loro e tradurre il più possibile le loro richieste alle operatrici che non capiscono la lingua, ma sembrano già conoscere bene il problema; ci riferiscono infatti che i ragazzi chiedono scarpe quando queste sono state distribuite a tutti ma da molti rifiutate perché non corrispondevano al numero esatto o “non piacevano”. Stessa cosa pure per felpe e pantaloni. Dal canto loro, i minori ribadiscono il fatto che non a tutti sono state date le calzature e che molti hanno dovuto attendere settimane, rimbalzati da una promessa all’altra: “Dopo due settimane hanno dato le scarpe a qualcuno ma non a tutti. Io ho ancora le infradito e fa freddo”. “In questo posto non c’è niente: scarpe, vestiti, scuola. Ci dicono una cosa poi non la mantengono mai. Anche ieri ci hanno promesso che oggi tutti avremmo avuto le scarpe ma ancora niente. Se non ci lamentiamo continuiamo così per sempre”.
Sappiamo che due giorni fa, in seguito ad una protesta, sono state chiamate le forze dell’ordine che hanno discusso con il responsabile; anche oggi, dopo una trentina di minuti, fanno ingresso dal cancello tre auto dei carabinieri chiamati dalle operatrici nel pieno della discussione. Con loro arrivano anche altri operatori, tra cui una donna con cui i ragazzi sembrano avere un rapporto di maggior fiducia. Nessuno di loro parla il francese, l’inglese o un’altra lingua veicolare, se non qualche parola. Ci troviamo quindi in ufficio ed assistiamo ad una frettolosa distribuzione di alcune scarpe rimaste, con i più che continuano a protestare all’esterno insieme agli ultimi arrivati lasciati ancora attendere in un angolo. Sollecitati dal maresciallo dei carabinieri, riportiamo le informazioni raccolte parlando con gli operatori ed i ragazzi nel corso anche delle ultime settimane. E’ in questo momento che veniamo raggiunti da un uomo, presumibilmente un operatore, il quale suggerisce al maresciallo di portare i quattro o cinque ragazzi più agitati in caserma per dare una lezione che potrebbero riferire anche agli altri: prontamente gli ricordiamo i diversi ruoli e compiti di carabinieri ed operatori e facciamo notare come la proposta che rimanda alla logica del “punire uno per educarne cento” sia contraria ad ogni prassi etica, educativa, assistenziale e legale che gli operatori di un centro sono tenuti a fare. Per il momento la questione sembra cadere nel vuoto, ma non la nostra idea di un modus operandi che segua questa logica e venga presumibilmente adottato dagli operatori in nostra assenza. Ci vengono mostrate anche delle firme, che i ragazzi sembrano aver apposto per accettazione del materiale distribuito, oltre al kit, in date comunque spesso lontane dall’ingresso e che in ogni caso non danno riscontro di un effettiva comprensione della cosa da parte dei minori, vista la grossa barriera linguistica che si interpone con gli operatori. Viene infine promessa una distribuzione di tutto ciò che manca entro fine giornata, la tensione cala e i carabinieri lasciano il centro.
Rimaniamo a parlare con alcuni ragazzi che non hanno partecipato alla discussione, prevalentemente anglofoni, trattenendoci a lungo fuori dal centro. A differenza dei loro compagni di lingua francese, che ostentavano rumorosamente la loro esasperazione, sembrano decisamente spenti e chiusi nella loro preoccupazione. Parliamo delle loro giornate, trascinate nella quotidianità ripetitiva e sfiancante degli spazi del centro, passate tra la camera da letto, la sala Tv e l’invio di messaggi con il cellulare, più qualche partita a calcio con gli altri ospiti. La sensazione è di immobilità totale, dove pure i propri interessi e le aspirazioni mai ascoltate vengono lentamente messe da parte. “Non so cosa mi aspetta, quando avrò i documenti, quanto devo fermarmi qui”. “Gli operatori parlano tutti italiano, ma noi non riusciamo a capirlo e non possiamo impararlo da soli”. “Ultimamente non riesco a dormire e spesso ho pensato che questa non fosse nemmeno l’Italia”. “Parlare è inutile, si accorgono che ci siamo solo quando firmiamo per prendere i pasti”.
Nessuno fa accenno alla discussione di poco prima, fino a quando un abitante della zona si affaccia per dare un giubbotto ad un ragazzo, dicendo che lo vede passare sempre solo con una felpa. “Nel centro anche l’acqua è fredda e c’è spesso solo la mattina. Ci hanno dato dei soldi ma non abbiamo un posto dove possiamo comprarci vestiti o cibo, tutto troppo lontano. Quando facciamo qualche domanda, l’unica risposta è che ci trasferiranno presto, senza altre spiegazioni”. “Io voglio andare a scuola e giocare a calcio.” – ci dice L., visibilmente molto giovane ma in grado di parlare un ottimo inglese e rianimare un po’ la discussione – “Ho sedici anni ma in Gambia sapevo già tre lingue, spero di non dimenticarle”. Restiamo in silenzio, completamente soli in mezzo all’unica strada deserta che porta verso le altre case sparpagliate nei boschi, fino a quando un forte temporale rimanda ognuno di corsa per la propria strada.
Oggi riceviamo un messaggio da parte di uno dei ragazzi: “Ieri ho finalmente avuto le scarpe. Non vedo l’ora di usarle per andare molto lontano da qui”.
Lucia Borghi
Borderline Sicilia Onlus