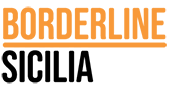Due volte sfruttate. Le donne rumene nella “fascia trasformata” del ragusano
di Davide Carnemolla, Claudia Di Franco, Ester Moschini, Alessandra Sciurba
a cura di Alessandra Sciurba
da meltingpot.org
1) Premesse: il lavoro agricolo migrante nella “fascia trasformata” del ragusano.
Qualche dato generale sullo sfruttamento agricolo dei migranti in Sicilia
Secondo i dati riportati dal primo rapporto su Agromafie e caporalato, curato dell’osservatorio Placido Rizzotto della Flai Cgil, gli occupati nel settore agro-alimentare in Sicilia sono 103.150, di cui 55.790 solo nel comparto agricolo.
I lavoratori di origine straniera ammontano a circa 25.200. Le nazionalità più presenti sono quella rumena con 11.000 lavoratori, quella tunisina con 8.150 lavoratori e quella albanese con 1.800 lavoratori. In particolare, i distretti in cui l’occupazione di manodopera immigrata è maggiore sono quelli di Bronte a Catania e dell’Altopiano e della fascia costiera nel ragusano. Questo fattore non è casuale poiché l’occupazione nel settore agricolo dipende dai cicli di produzione che variano a seconda delle colture prodotte e della provincia interessata.
A livello regionale e interregionale, si verificano spostamenti massicci di manodopera immigrata verso diverse zone a seconda dei cicli di produzione. Nella provincia di Catania e nell’Altopiano ragusano, nei mesi da giugno a dicembre arrivano tantissimi lavoratori mobili che si sommano a quelli stanziali e che, conclusa la stagione, ritornano verso il centro-nord e in particolare verso la Toscana e l’Emilia Romagna per il nuovo ciclo di produzione.
I tipi di sfruttamento sono molteplici: da truffe e inganni sull’ammontare dei salari o sulle ore lavorative, a contratti promessi e mai sottoscritti, il tutto condito molto spesso da minacce e violenze psicofisiche.
Dal primo insediamento tunisino alla nuova presenza dei cittadini rumeni nella Provincia di Ragusa
La cosiddetta “fascia trasformata” del territorio ragusano è quella in cui alla coltivazione stagionale si è sostituita la cultura in serra, che produce primizie per tutto l’anno. Questa fascia si sviluppa principalmente nel triangolo che va da Vittoria a s. Croce Camerina a Marina di Acate, e d è qui che la conversione del lavoro agricolo stagionale in culture permanenti ha cambiato il paesaggio e la composizione degli abitanti del territorio, con la presenza attuale di circa 15/20.000 lavoratori migranti nelle serre.
Come spiega Vincenzo Lamonica della Caritas di Ragusa, impegnato ogni anno nella stesura della parte siciliana del famoso Dossier Caritas-Migrantes,
“Questa trasformazione ha portato i primi cittadini immigrati a rispondere alla nuova offerta di lavoro che si era in tal modo creata. E del resto, quale italiano, avendo altre possibilità, sceglierebbe di lavorare nelle serre a queste condizioni? Si tratta di un lavoro massacrante, a temperature spesso altissime, e molto pericoloso per la salute a causa dei fitofarmaci e dei diserbanti che hanno conseguenze sull’apparato respiratorio, sulla pelle, sugli occhi”.
Il fenomeno del lavoro agricolo migrante risale dunque in quest’area già dalla fine degli anni Settanta. A quel periodo va ricondotta la cosiddetta “scoperta dell’oro verde”, il cui sfruttamento vede impiegati fin da subito lavoratori tunisini provenienti dalla zona più povera del loro paese.
“Questi migranti si sono insediati attraverso il classico meccanismo della catena migratoria e poi sono rimasti stabilmente”, ci dice ancora Vincenzo. “Bisogna tenere presente che in questi luoghi non si è mai storicamente data la presenza dei grandi latifondi, come in tante parti del Sud Italia, ma che parliamo spesso di piccole, e anche piccolissime proprietà. Questo tipo di realtà ha favorito una sorta di fidelizzazione anche dei lavoratori migranti, dapprima in gran parte irregolari anche rispetto al permesso di soggiorno, all’interno di un’economia difficilissima da sottomettere a regoli e controlli”.
Qui se il lavoro non è nero (e lo è nel 60% dei casi), è grigio, ovvero si dichiara solo una parte dei giorni lavorati, da 51 a 182 (mentre in realtà sono in media 260) in modo che il lavoratore possa integrare il salario dato dal proprietario terriero con il sussidio di disoccupazione pagato dall’Inps.
Il contratto, quando esiste, rimane così di tipo stagionale, mentre la paga giornaliera è di norma inferiore a quella dichiarata e comunque molto più bassa degli almeno 50 euro che dovrebbero essere garantiti da contratto sindacale.
Vincenzo, che ha accettato di incontrarci nel suo ufficio in una delle strade più centrali di Ragusa, continua a rispondere con grande competenza e gentilezza a tutte le nostre domande. La sua giovane collega, Anita Adamo, supporta la sua narrazione attraverso dati che ci mostra aiutandoci a interpretarli. A entrambi interessa molto farci capire davvero in quale contesto generale si inserisca il fenomeno di cui stanno parlando:
“Nonostante la diffusa irregolarità del lavoro, negli anni i primi migranti arrivati, tutti uomini tunisini, sono diventati una presenza sempre più stabile, iniziando a ottenere i permessi di soggiorno, ad avviare i ricongiungimenti familiari, persino a rivendicare diritti sindacali. Ad oggi ci sono non solo le seconde generazioni di questa migrazione tunisina, ma anche le terze, che hanno spesso avuto origine dai numerosi matrimoni misti che si sono verificati. Pensate che all’inizio del 2000 le persone di origine tunisina rappresentavano circa il 40% dei 2000 abitanti di S. Croce Camerina. Molti di loro sono adesso regolari rispetto al permesso di soggiorno, anche se il lavoro resta permanentemente ‘grigio’ ”.
La predominanza dei lavoratori tunisini sul territorio, racconta ancora Vincenzo, è stata sfidata per la prima volta solo agli albori del nuovo secolo dalla presenza degli albanesi. Ma il loro numero non era considerevole, e questi nuovi arrivati si erano dedicati fin da subito anche al settore dell’edilizia:
“ La vera concorrenza inizia solo dal 2007, dopo l’ingresso della Romania in Europa, ed è allora che scoppia una vera e propria guerra tra poveri”
Secondo stime della Caritas ragusana, su quasi 19.000 lavoratori non italiani iscritti all’Inail nel ragusano, circa 12.000 lavorano nell’agricoltura, mentre nel 2011 ci sono state 1225 assunzioni di rumeni nel comune di Ragusa, su circa 5500 nuove assunzioni di cittadini della stessa nazionalità nell’intera Sicilia. Se la Provincia di Ragusa resta l’unica siciliana con preponderanza tunisina, quindi, i rumeni sono ormai pochissimi di meno: si parla di 5981 cittadini tunisini regolarmente presenti nel 2012, a fronte di 5487 rumeni. A questi numeri va ovviamente sommata la cifra di tutte le persone che non risultano regolarmente iscritte negli elenchi.
I cittadini rumeni, oltre che lavorare nelle serre, sono la quasi totalità dei lavoratori nei piccoli centri di trasformazione dei prodotti agricoli, dove vengono pagate solo le ore effettivamente lavorate (2 o 3 al giorno), a fronte di giornate intere passate aspettando l’arrivo della merce dalle serre. In questo comparto lavorativo i controlli sono più facili da effettuare, e quindi i lavoratori non devono avere problemi di permessi di soggiorno.
In generale, da quando i cittadini rumeni sono diventati cittadini europei, i datori di lavoro, impiegando loro al posto dei tunisini, non rischiano più di incorrere nel reato di favoreggiamento o sfruttamento della migrazione clandestina. L’avere acquisito la cittadinanza Ue, paradossalmente, ha reso queste persone più facilmente sfruttabili all’interno di un sistema produttivo che li vede di norma come ultimo anello di cuna catena in cui italiani e tunisini vengono prima di loro. La gerarchia appare chiara anche solo se si guarda ai salari, visto che i tunisini vengono pagati da 25 a 30 euro al giorno, mentre i rumeni da 10 a 15.
Se molti tunisini hanno iniziato a fare ritorno al loro paese d’origine proprio a causa di questa nuova concorrenza, alcuni tra loro si sono invece organizzati, infatti, per sfruttare la nuova situazione. Qualcuno è anche riuscito a diventare proprietario di piccolissime aziende. Altri svolgono mansioni da “caporale” (nonostante nel ragusano, I rapporti tra proprietari agricoli e braccianti siano per lo più diretti), anche attraverso forme di sfruttamento “creativo”, come quella che prevede che ai rumeni sia offerto un periodo di prova di una settimana nelle serre prima dell’assunzione, previo pagamento all’intermediario di circa 100 euro. Alla fine il lavoratore non viene mai assunto e ci guadagnano tutti tranne chi ha lavorato. Anche e soprattutto il proprietario italiano guadagna la settimana lavorativa pagandola a bassissimo prezzo o non pagandola per niente.
I proprietari agricoli della zona giustificano questa e altre forme di sfruttamento adducendo il fatto di essere strozzati dalle dinamiche del mercato, che paga pochissimo la produzione anche a fronte di un prezzo al pubblico della merce molto elevato, e di avere assoluto bisogno, quindi, di risparmiare almeno sulla manodopera. La loro difficile situazione, però, deriva anche certamente dalla scelta storica e dal limite culturale di avere sempre puntato su grandi quantità di prodotto, senza curarne troppo la qualità, e senza mai consorziarsi per diventare più forti.
2) Donne che lavorano nelle serre: tra sfruttamento e ricatto sessuale
Oltre al diverso “potere” all’interno del sistema della produzione agricola del territorio, e oltre alla loro appartenenza all’Unione europea, c’è un’ulteriore differenza fondamentale tra i lavoratori rumeni e i loro “colleghi” nordafricani: la maggior parte dei migranti provenienti dalla Romania per lavorare nelle serre del ragusano sono donne.
Se altrove le donne migranti provenienti dai paesi dell’ex blocco sovietico trovano come destinazione “naturale”, nel contesto della segmentazione etnica e di genere del mercato del lavoro, quella di prestare servizio nelle case degli italiani, diventando le cosiddette “colf e badanti” di cui il nostro paese dal welfare collassato ha estremo bisogno, qui queste donne arrivano sapendo già che le aspetterà la campagna.
Quel che è meno chiaro è se esse già prima di partire siano a conoscenza, fino in fondo, anche delle condizioni lavorative che incontreranno e della realtà ambigua e torbida in cui il loro lavoro appare strutturalmente inserito.
A parlarci per la prima volta di loro è Ausilia Cosentini, un’assistente sociale che lavora per la Cooperativa Proxima, impegnata sul fronte della tutela delle donne in relazione all’art. 18 e all’art. 13 del Testo Unico sull’immigrazione, quelli che proteggono dalla tratta e dal grave sfruttamento. La incontriamo nel grande appartamento del progetto Nova Vita, in cui abitano in questo momento 5 donne nigeriane con i loro bambini. Adulte e piccolini hanno gli occhi sereni e nessuna difficoltà a parlare e sorridere.
“Il nostro obiettivo principale è l’emersione dei fenomeni di tratta, ma anche di grave sfruttamento, da cui questo territorio è evidentemente segnato in modo estremo”, inizia a raccontarci Ausilia. “Le donne che lavorano nelle serre sono tra le prime vittime, e non solo dal punto di vista dello sfruttamento lavorativo. Vi do solo un dato, che potrete approfondire: gli ambulatori qui intorno sono pieni di donne rumene, anche giovanissime, che vi si recano chiedendo un’interruzione volontaria della gravidanza”.
L’indomani, effettivamente, ne abbiamo conferma anche dalla dottoressa Elena Afonina, che abbiamo incontrato nell’ambulatorio di Ispica. Lì, come negli altri ambulatori del territorio, la dottoressa riceve migranti con il cosiddetto tesserino STP, per “stranieri temporaneamente presenti” (in realtà persone che il più delle volte abitano sul territorio da anni ma sono senza permesso di soggiorno) o, nel caso dei rumeni, persone che accedono al servizio ENI per i comunitari e che non riescono comunque ad avere la residenza formale. La dottoressa ci rende partecipi della realtà sbalorditiva di una Vittoria, piccola cittadina della profonda Sicilia, diventata il primo comune in Italia, in proporzione, per numero di IVG effettuate:
“Le donne rumene vengono qui accompagnate sempre da uomini, il più delle volte italiani ma anche tunisini e in qualche caso albanesi. Spesso sono poco più che ragazzine. Loro restano sedute con lo sguardo fisso a terra e gli uomini parlano al posto loro. Dicono di essere amici o conoscenti, e hanno molta cura di non lasciarle mai da sole con me. Solo quando le donne arrivano con un compagno della loro nazionalità, cosa che avviene negli altri comuni, e quasi mai a Vittoria, lo fanno di solito perché vogliono tenere il bambino, e hanno tutt’altro tipo di atteggiamento. Nel 2011 un tunisino mi ha portato tre donne rumene, tutte incinta, per farle abortire. Le ragazze parlavano poco e solo in italiano perché lui potesse capire quel che dicevano. Nell’unico momento in cui sono rimasta sola con loro mi hanno detto soltanto di lavorare nelle serre di cui lui era proprietario. Tutte queste donne lavorano nelle serre, pochissime nelle famiglie. Quelle che fanno le “badanti”, sono riuscite a raccontarmi certe volte che andare a letto con la persona che assistono, anche se si tratta di anziani, o con i loro figli, è un modo per integrare il loro magro stipendio. Questo fenomeno però, che accomuna lo sfruttamento lavorativo a quello sessuale, è molto diffuso soprattutto nelle campagne. In questo momento sto seguendo una ragazzina di 18 anni, all’ambulatorio di Vittoria, che è rimasta incinta ma è troppo in là con la gravidanza per interromperla. Lei cercherà di dare in affidamento il bambino subito dopo la nascita. Io posso solo mandarle ai consultori, dove di solito non ricevono molte informazioni e quando tornano qui dopo l’aborto non hanno mai una prescrizione per acquistare degli anticoncezionali. Con queste donne è comunque difficilissimo costruire un rapporto sano tra medico e paziente, e anche assistenti sociali e psicologi fanno grande fatica in questo senso, e la verità non emerge mai”.
La “verità “ è fatta di condizioni di semi-schiavitù unite a un costante ricatto sessuale. Questo il quadro che inizia chiaramente a delinearsi. Il tutto consumato nell’isolamento silenzioso nelle campagne. Come aveva raccontato Ausilia:
“Le donne soprattutto, quelle che vorremmo aiutare, sono sempre reticenti, o forse sono semplicemente meno libere. I luoghi di lavoro sono gli stessi in cui abitano, dentro case di legno o di pietra, catapecchie improvvisate o magazzini, che si trovano tutti in prossimità delle serre. Sono luoghi sperduti, a volte blindati da cancelli e filo spinato con cani enormi che fanno la guardia”.
Qui i datori di lavoro esercitano una vera e propria costrizione psicologica sulle loro lavoratrici, promettendo maggiori compensi a chi accondiscende alla loro richiesta di prestazioni sessuali. Non si tratta di vera e propria costrizione fisica, si potrebbe dire, ma quando il potere negoziale è nullo e l’alternativa più verosimile è la perdita del lavoro, allora il limite tra scelta e costrizione è davvero labile.
Le lavoratrici rumene, che raccontano al massimo di avere una relazione sentimentale con il loro datore di lavoro, sembrano infatti “accettare” di sottomettersi a tutto questo. Ma hanno quasi sempre una famiglia in Romania, spessissimo dei figli piccoli, che aspettano le loro rimesse per potere vivere: “questo sembra essere il loro unico pensiero”, ci hanno detto tutti. La tensione tra imposizione, da un lato, e accettazione della situazione, dall’altro, è una componente che rende ancora più difficile denunciare la condizione di queste donne come segnata da violenza palese, nonostante esse siano soggette a un triplice sfruttamento che vede protagonisti uomini italiani, tunisini, e loro connazionali rumeni.
Chi conosce bene la situazione, però, come Anita Adamo e Vincenzo Lamonica, non vuole neanche sentire parlare di “libera scelta” o di “donne rumene disposte a tutto”. I due ricercatori della Caritas non tollerano compromessi nel descrivere una situazione generalizzata di abuso psicologico e sessuale che nessuno sul territorio sembra riuscire o avere la volontà di contrastare, tranne Proxima e Cgil, o preti coraggiosi come Don Beniamino Sacco di Vittoria:
“Non sempre i migranti che arrivano qui sono ben visti dalla popolazione”, ci ha raccontato il prete. “Alcuni anni fa, subito dopo l’arrivo di una ventina di loro al mio centro di ospitalità, venne da me un gruppo di cittadini di Vittoria che mi disse: Non vogliamo queste persone. O se ne vanno loro o ce ne andiamo noi. E io risposi: allora andatevene voi!”
Padre Beniamino è sempre stato molto attivo nel sostegno agli immigrati, trasformando la parrocchia in un vero e proprio centro aperto di prima accoglienza in cui ospita minori stranieri non accompagnati, immigrati sbarcarti a Pozzallo o a Siracusa, donne lavoratrici rimaste incinta che scelgono di non abortire. Lo abbiamo raggiunto a Vittoria, proprio lì, a Santo Spirito, e ha accettato volentieri di offrirci il suo punto di vista:
“L’arrivo di queste donne dell’Est ha scombussolato il panorama agricolo siciliano, in cui la moglie del proprietario sta a casa e difficilmente lavora nelle campagne. Questa presenza femminile ha destato inizialmente curiosità e in seguito un vero e proprio scompenso sociale. Si cominciava a dire che i proprietari avessero ‘riscoperto il piacere della campagna’ poiché alla sera tornavano a casa sempre più tardi. Molte famiglie sono entrate in crisi”.
Padre Beniamino ci parla senza mezzi termini dei cosiddetti “festini agricoli”, che lui è stato il primo a denunciare pubblicamente:
“Si tratta di vere e proprie feste a sfondo sessuale in cui i proprietari e datori di lavoro mettono a disposizione di amici e conoscenti le proprie lavoratrici. I festini sono diffusi soprattutto nelle piccole aziende a conduzione familiare, perché le grandi aziende sono più controllate. Hanno luogo tra le serre stesse, o in cascine isolate, o talvolta anche in disco-bar poco frequentati. Le ragazze coinvolte sono lavoratrici rumene giovani che spesso hanno dai 20 ai 24 anni. A volte si tratta anche di ragazze figlie di dipendenti a cui il proprietario affitta la cascina. Ogni tanto succede anche che siano i figli dei proprietari a sfruttarle. Una volta che si entra in questo giro è difficile uscirne. Non c’è una rete familiare o amicale forte a sostegno di queste donne, né esistono legami solidaristici tra lavoratrici, un po’ per la segregazione cui sono costrette, un po’ per la concorrenza innescata dagli stessi datori di lavoro che innescano una sorta di competizione tra di loro dettata dalla disperazione”.
La realtà di questi “festini agricoli” giustificherebbe anche l’incremento di gravidanze e di richieste di IVG di cui ci hanno parlato la dottoressa Afonina e Ausilia. Padre Beniamino ci ha raccontato anche come nel giro di due anni lui stesso abbia ospitato presso la sua parrocchia svariate donne romene che non avevano potuto richiedere l’IVG perché oltre il terzo mese di gravidanza:
“Sono state accompagnate e abbandonate da uomini italiani. Di solito, questi accompagnatori dicono di averle trovate per strada e di avere deciso di portarle da lui, ma dai racconti di alcune ragazze si capisce che quegli uomini sono i datori di lavoro stessi che se ne vogliono sbarazzare percependole come un rischio per l’unità della propria famiglia. Alcune di queste donne, dopo avere partorito, hanno deciso di dare il bambino in adozione e di tornare a lavorare nelle serre, poche altre hanno tenuto il bambino e non sono più tornate a lavorare”.
Il prete parla poi di veri e propri stupri riferendosi alla violenza esercitata dai lavoratori e dai “mediatori” romeni e tunisini ancora sulle lavoratrici romene. Gli uomini si ubriacano e queste donne, nell’isolamento delle serre in cui vivono in condizioni estreme di promiscuità e degrado, non hanno scampo:
“Spesso, la difficoltà di trovare una sistemazione logistica costringe queste donne ad abitare in situazioni di promiscuità con romeni o tunisini, anche tramite la mediazioni di donne connazionali più anziane che agiscono un po’ come maman e che creano un vero e proprio mercato da cui traggono un personale profitto. Questo vale anche nella gestione delle badanti da cui poi pretendono un contributo. È una situazione non controllata e non controllabile. Non si sa dove queste lavoratrici siano collocate di preciso, spesso si tratta di cascine isolate nelle campagne dove manca tutto”.
Secondo padre Beniamino, è verosimile che, oltre alle lavoratrici che nelle serre vengono sfruttate anche sessualmente, ci sia una vera e propria tratta di ragazze per lo sfruttamento sessuale. Probabilmente, esistono forme di connivenza e collaborazione di alcuni datori di lavoro con vere e proprie organizzazioni criminali, ma attualmente non ci sono indagini in questo senso:
“Il problema vero è una certa assuefazione a uno stile di vita degradato e che non dà fastidio a nessuno perché poco visibile. Non c’è attenzione a livello sociale”.
Padre Beniamino ci conferma così, desolato, l’assenza totale delle istituzioni e il loro silenzio assordante:
“La gente lo sa che ci sono questi festini agricoli, chi ha partecipato ne ha parlato in giro. Ma chi denuncia, viene accusato di agire contro la cittadinanza e il territorio. Io per esempio ho denunciato un datore di lavoro che faceva lavorare una donna romena 17 ore al giorno per 20 euro. Pretendeva dalla stessa 100 euro alla settimana per l’alloggio a cui poi aggiungere il vitto, e in più pretendeva anche delle prestazioni sessuali. Dato che lei si era rifiutata, lui ha preteso il passaporto per poi ricattarla. Allora io l’ho denunciato e questo mio gesto non è stato apprezzato”.
Se grazie alla denuncia di Padre Beniamino almeno questo datore di lavoro è stato arrestato, in generale, infatti, come ci aveva raccontato anche Ausilia Cosentini, l’atteggiamento è di completa omertà:
“Per chiarire quello che avviene nelle serre, la mia cooperativa – ci ha detto Ausilia – ha convocato un tavolo tecnico con le forze dell’ordine, ma non mi sento di dire che le sentiamo presenti in questa situazione. Loro si muovono sempre nella misura in cui il fenomeno viene percepito come un problema di sicurezza sociale per gli italiani, come avverrebbe se le donne si prostituissero nel centro di Vittoria o di Ragusa. Nessuno difende queste donne, così isolate, anche nei casi in cui non arrivano da sole ma con il marito o il compagno, perché questo viene separato da loro o finisce per rendersi complice del sistema. La mancanza di solidarietà tra i rumeni, e la loro mentalità omertosa, sembra incastrarsi perfettamente con quella altrettanto omertosa del territorio”.
3) Il Solidal Transfert. Vedere coi nostri occhi la realtà delle serre
Per cercare di fare emergere questa realtà e di proteggere in qualche modo le donne sfruttate, la cooperativa Proxima, in partenariato con la Flai-Cgil e la Camera del Lavoro di Vittoria, ha avviato da meno di un anno un progetto estremamente intelligente che potrebbe portare importanti risultati. Si tratta del “Solidal Transfert”, un pullmino che attraversa le campagne del ragusano, fornendo ai migranti un passaggio per andare a fare la spesa, ricaricare i telefoni, e in generali spostarsi senza bisogno di pagare i “caporali” all’interno di un territorio in cui vivono segregati nella loro zona di lavoro. Un’altra fonte di guadagno per i mediatori è infatti costituita da un vero e proprio racket del trasporto per l’accesso ai servizi. Nelle campagne non esiste una rete di mezzi pubblici che colleghi capillarmente le zone di lavoro con i centri abitati.
“Queste persone vivono nel massimo dell’isolamento” – ci aveva detto Ausilia– “lavorano in campagna e non conoscono spesso neanche il centro urbano più vicino e il contesto socio-ambientale in cui si trovano. Se provano a spostarsi vengono sfruttate anche in questo senso, con la richiesta di una cifra che arriva fino a 15 euro per fare 4 km”.
L’isolamento, ovviamente, è ancora maggiore per le donne:
“Spesso, sono i partner o i colleghi romeni a recarsi a fare la spesa, mentre le donne di fatto sono meno libere, vivono e lavorano nelle serre senza mai potersi allontanare né avere contatti con nessuno”.
Così è nata l’idea di offrire un servizio di sostegno alla mobilità che, attraverso l’utilizzo del pulmino finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità, aiutasse questi lavoratori, e soprattutto queste lavoratrici, a non essere totalmente dipendenti dai datori di lavoro o da autisti abusivi, cercando di fornire al tempo stesso informazioni anche sui diritti e la previdenza. C’è anche un numero verde che i lavoratori e le lavoratrici possono chiamare quando hanno bisogno.
Il Solidal Tranfert si muove sul territorio tre volte a settimana attraversando la distesa immensa di serre. Il tragitto coperto è quello che passa da Marina di Acate – Costa Esperia – Baia Dorica – Contrada Arcerito – Contrada Resinè, per arrivare fino al centro di Scoglitti e Vittoria percorrendo la strada Statale. Come ha spiegato ancora Ausilia:
“ Il Solidal Transfert fornisce un servizio che ha immediate ricadute positive per le persone che salgono a bordo, perché le sottrae al racket della mobilità, ma è anche un modo per “agganciarle ”. Nel tragitto che si fa, dando loro questo passaggio, l’operatore di Proxima, sempre insieme a qualcuno della Cgil, cerca di instaurare una relazione, di capire quali siano i loro principali problemi. Non è una cosa facile, perché bisogna vincere la diffidenza che queste persone hanno per ogni servizio gratuito, visto che sono solo abituate a essere sfruttate. La comunità rumena, isolata e frammentata più delle altre, è quella più difficile da approcciare, soprattutto le donne. Ogni volta che riusciamo a dare un passaggio a qualcuna, emerge qualche elemento in più, ma poi è difficile approfondirlo. Fino ad ora abbiamo avuto un solo caso di sfruttamento sessuale dichiarato”.
Nella casa famiglia del progetto Nova vita, non a caso, sono passate negli anni pochissime donne rumene.
Poter vedere di persona il “dominio” delle serre nella zona di Vittoria e, di conseguenza, le condizioni in cui si trovano a lavorare le donne migranti è sicuramente il modo migliore per provare veramente a comprendere questo microcosmo asfittico. E avere l’opportunità di farlo guidati da Emanuele Bellassai, l’operatore del progetto Solidal Transfert, è sicuramente la via più immediata per “scontrarci” subito con la realtà prima descrittaci da Ausilia, da Vincenzo e da Padre Beniamino.
Saliamo con Emanuele sul pullmino nel primo pomeriggio di una caldissima giornata di fine luglio. Da Ragusa ci spostiamo verso Ovest avvicinandoci a Vittoria percorrendo le strade più vicine alla costa. Davanti ai nostri occhi si estendono distese immense di serre in un paesaggio quasi surreale nel quale il bianco dei tendoni copre tutti gli altri colori. Le serre – ora vuote per il periodo di pausa estiva – invadono ogni angolo del territorio arrivando in alcune zone – come Marina di Acate – a ridosso della spiaggia. Lì, a pochi metri da esse, locali e turisti stanno trascorrendo una giornata al mare.
Il caldo e l’afa si fanno sempre più forti, e noi ci immedesimiamo in chi con quel clima lavora dentro le serre. Emanuele ci porta in altre contrade percorrendo stradine secondarie spesso poco accessibili e visibili. Sono zone lontane da tutto e da tutti, dove i piccoli e medi proprietari terrieri erigono il loro feudo e decidono liberamente quali ricatti e soprusi perpetrare.
Mentre ci inoltriamo per le campagne, Emanuele ci racconta un po’ della sua esperienza maturata in tanti chilometri percorsi alla ricerca di qualcuno da aiutare:
“Quando abbiamo cominciato c’era tanta diffidenza e solo pochi lavoratori , tutti uomini, fruivano del nostro servizio. È passato del tempo ma, dopo i primi mesi, anche alcune lavoratrici rumene hanno cominciato a prendere il pulmino per svolgere le proprie commissioni nei centri abitati”.
Durante il tragitto a volte capita che le donne, superato il timore iniziale, riescano ad aprirsi un po’. Così, facendo la spola tra serre e supermercati, Emanuele ha ascoltato la storia alcune di loro. Il primo dei problemi – ci spiega -, quello che rende difficile ogni prospettiva di intervento efficace, è semplicemente la mancanza di alternative concrete da offrire:
“All’interno delle serre si trova sempre lavoro per sé, per il partner, per i figli più grandi, ma se ci si decide a denunciare dove trovare un altro lavoro? Come trovare da mangiare per la propria famiglia?”
A partire da questa consapevolezza Emanuele ha comunque aiutato alcune donne a fare emergere alcune realtà terribili. Ci racconta la storia di una di loro, venuta a parlare della sorella che, dopo le minacce continue del suo datore di lavoro, aveva deciso di bere l’acido riuscendo quasi ad ammazzarsi.
D’un tratto, mentre Emanuele ci parla, il telefono della cooperativa inizia a squillare. È Liliana, una signora rumena che ha chiamato il numero verde per chiedere di essere accompagnata al supermercato e poi a ricaricare la scheda telefonica.
Passiamo a prenderla all’ingresso di una proprietà recintata. Esce dal cancello accompagnata da suo marito. Tutti e due hanno una cinquantina d’anni. Lui non parla una parola di italiano, ed è questo il motivo per cui Liliana lavora nelle serre:
“Come posso lasciarlo solo qui? Lui non parla niente, devo stare con lui. Prima facevo la badante in Sardegna e poi a Perugia ma in quel lavoro non potevo stare con mio marito. Così mandiamo i soldi a casa perché il figlio piccolo ancora studia. Quella grande è sociologa laureata e lavora”.
Liliana non ha le caratteristiche per rientrare tra le donne sfruttate anche sessualmente. È avanti con gli anni, alta e massiccia, vive con suo marito. In questo senso appare quasi “fortunata”, anche se come tutte le altre sue connazionali che lavorano come lei, subisce un continuo sfruttamento lavorativo cui non può opporre alcun potere né alcun diritto da esercitare:
“Domani torno nella campagna dove lavoravo prima per farmi pagare. Non mi pagano più. Dicono sempre: mercoledì vieni, e poi vado mercoledì e dicono: vieni sabato. È sempre così”.
E se non volessero proprio pagarla? Chiediamo ad Emanuele. “Non potrebbe farci proprio niente”, ci risponde senza smettere di guardare la strada.
In Sicilia gli abitanti della provincia di Ragusa vengono chiamati “i babbi”, cioè gli ingenui. Ciò avviene secondo alcuni perché sono stati spesso considerati meno agguerriti e rivoltosi rispetto agli altri siciliani; secondo altri perché la “densità mafiosa” della zona è più bassa rispetto alle altre province dell’isola. In questo senso il “babbo” diventerebbe quindi chi non è mafioso.
A Vittoria e dintorni forse le persone sono un po’ meno “babbe” in quest’ultimo senso, perché il velo di silenzio si sovrappone a quello dell’indifferenza emarginando ancora di più i migranti che vivono e lavorano in quel limbo che sorge tra le città e le spiagge.
Proprio per questo il progetto del Solidal Trasnfert ha tanto valore anche solo nel momento in cui il pulmino si trasforma da mero mezzo di trasporto a luogo sicuro di ascolto.
Emanuele e Bernardette, l’operatrice della Cgil che lo accompagna sempre, stanno diventando lentamente dei punti di riferimento per queste donne, lavoratrici dei campi che sono mani e corpi nascosti arrivati dalle zone rurali di una Romania segnata da una povertà estrema che continua a dilagare.
Viaggiando insieme a loro, in questi pochi giorni così intensi, è tornata alla mente una realtà che alcuni di noi hanno conosciuto in Tunisia durante la Carovana dell’associazione Ya Basta, nella primavera precedente.
In varie zone rurali della Tunisia, infatti, – soprattutto nelle aree centrali del paese- il lavoro è tutto sulle spalle delle donne che vengono pagate sei o sette dinari al giorno, una cifra per cui gli uomini non accetterebbero mai di lavorare.
Queste donne ogni mattina escono di casa, si mettono ai bordi delle strade e attendono l’arrivo del “caporale” che le porti – ovviamente a pagamento – nelle campagne dove inizieranno le loro massacranti e interminabili giornate di lavoro. Le chiamano “le matite colorate” perché sono ammassate con i loro abiti variopinti nei furgoni che le trasportano, proprio come le matite colorate in un astuccio.
Oltre alle enormi fatiche del lavoro nei campi anche loro – come le donne romene in Sicilia – sono vittime di violenze e ricatti a sfondo sessuale. E anche loro sopportano per far sì che i loro figli non si trovino costretti a fare quello che loro stanno facendo.
A Regueb, una delle città maggiormente interessate da queste forme di sfruttamento, è nata dopo la Rivoluzione Tunisina l’associazione “Voix d’Eve” (la voce di Eva), formata da donne che lavorano per dar voce ad altre donne sfruttate e permettere loro di rivendicare i propri diritti.
Come gli operatori del Solidal transfert, queste giovani e coraggiose tunisine hanno avviato un progetto che prevede la possibilità di accompagnare le lavoratrici nei campi senza costringerle a pagare l’obolo ai caporali. E anche loro, durante i chilometri percorsi tra le campagne tunisine, provano a raccogliere le loro storie.
Un triste “gemellaggio” tra la Sicilia e la Tunisia che accomuna nello sfruttamento le donne tra una sponda e l’altra del Mediterraneo, ma che ci fa scoprire anche esperienze straordinarie di persone che non si arrendono alla realtà orribile delle cose:
“Siamo contenti di potervi raccontare la nostra esperienza e il nostro lavoro perché vediamo che vi interessa quello che facciamo” ci hanno detto Emanuele e Ausilia. “ Qui a volte ci sentiamo soli e non è facile incontrare qualcuno che capisca il nostro impegno”.
Perché in Sicilia come in Tunisia le nuove schiavitù sono più che mai diffuse e coperte da una cappa di interessi economici e di silenzi assordanti di cui le donne sono le prime vittime, ma anche, molto spesso e nonostante tutto, il primo orizzonte di dignità e speranza a cui guardare.
Durante il nostro secondo pomeriggio sul Solidal Transfert, la “vista guidata” raggiunge anche l’entroterra delle contrade situate tra Vittoria e S. Croce Camerina dove, tra una serra e l’altra, appaiono edifici grandi e moderni – quelli di padroni e padroncini – accanto a casette in pessime condizioni che sembrano abbandonate. È in queste ultime, come avevamo già saputo, che abitano le lavoratrici e i lavoratori migranti. E qui che si consumano i ricatti e le violenze sessuali di cui abbiamo tanto abbiamo ascoltato in questi giorni. Ma anche se siamo preparati, vederle coi nostri occhi fa effetto.
Emanuele è riuscito miracolosamente a combinare un appuntamento per incontrare due donne rumene in una di queste baracche. Ha detto che stiamo facendo una ricerca sul loro doppio ruolo di madri e di lavoratrici.
Il pulmino devia così dentro una strada di terra battuta che attraversa due file di serre dove si sta ancora lavorando. Sono gli ultimi minuti della breve pausa pranzo. Ci è concesso pochissimo tempo per incontrare Adriana e Ivana [1].
Scendiamo dal Solidal Transfert di fronte a una casupola di pietra a due piani. Poco più di un rudere. Affacciato alla scala che porta al piano superiore c’è un ragazzo con un braccio rotto e un occhio segnato da un evidente livido nero. Quando chiediamo cosa gli sia successo ci dice: sono caduto.
L’uomo rumeno che ci accoglie odora di alcol ed è sopra le righe in ogni gesto e in ogni parola del suo italiano improvvisato. Quando le chiediamo dove possiamo parlare, Adriana si volta verso di lui, i suoi occhi azzurri ci dicono che non può decidere niente senza prima chiedere a suo marito, che del resto non ci molla un attimo. Non si allontana neanche quando, solo donne, entriamo nello spazio stretto del piano terra, e gli chiediamo di lasciarci tra noi. Fa finta di andare nella piccola stanza accanto, di pietra nuda e umida come quella in cui siamo, e da lì risponde lui a tutte le domande che rivolgiamo a sua moglie, anche se lo facciamo a bassa voce. Tra noi c’è chi parla rumeno, diciamo, non abbiamo bisogno di interpreti. E poi l’italiano di Adriana è più che sufficiente. Ma non basta a convincerlo. Non ci lascerà in pace finché non saremo andati via.
Nonostante questa presenza opprimente, però, Adriana riesce comunque a dirci qualcosa, lasciando nel silenzio tra una parola e l’altra molto di più di quanto può raccontare dei suoi 44 anni di vita e di quegli ultimi 6 trascorsi nelle serre siciliane:
“Sono venuta qui con figlia piccola di due mesi e figlio grande di 13 anni. Il mio primo marito malato è rimasto a casa con l’altra figlia grande e dopo otto mesi è morto. Nelle serre, il grande badava alla bambina mentre io lavoravo. Stavano nella casa nella campagna, come qui. Quando ha iniziato a scuola la piccola è tornata in Romania, adesso ha 6 anni e vive con sua sorella grande che ne ha 27. La chiama mamma. Gli mando i soldi tutti i mesi. Sono da sola, serve lavorare per loro. Lavoro per tutti. Se non vengo a lavoro qua non ce l’hanno da mangiare. Quando vedo che ho fatto tanti soldi posso tornare a casa” .
Il marito si intromette ancora:
“Da noi le donne non sono come le italiane. Hanno gli stessi diritti, fanno le stesse cose dei maschi!”
Traduzione: si spaccano la schiena molto più degli uomini.
“Lascia parlare gli uomini” ci dice Adriana nell’unico momento in cui suo marito sembra effettivamente un po’ più lontano da noi. “Loro sono contenti se gli lasci fare quello che vogliono. E mentre tu lavori ti guardano e bevono il caffè”.
Ivana entra poco dopo. Si siede anche lei sul letto coperto da una stoffa sdrucita e che insieme al tavolo di legno e a due sedie è l’unico mobilio presente nella stanza. Ha l’aria più rilassata di Adriana, sembra un po’ più disinvolta, forse perché non ha nessun marito presente in quella serra.
Ha 41 anni, e con lei c’è una ragazzina di 11. È sua figlia:
“Non potevo stare lontana da lei, da Seva, sono troppo attaccata. Lei non può stare lontana da me e io non posso stare lontana da lei e allora viviamo insieme qui. L’ho lasciata solo un mese e 20 giorni due anni fa, quando ero appena partita, ma subito sono tornata indietro e l’ho ripresa. Nelle serre puoi vivere coi bambini. A casa di un vecchio non puoi portare i figli. Per questo ci sono nelle serre tante mamme rumene coi bambini”.
La piccola Sveva ci dice di essere contenta. Parla un italiano perfetto e cerca la nostra complicità di italiane. Va a scuola, e il suo problema è che l’anno prossimo, visto che si sono spostati di serra, lo scuolabus forse non riuscirà a venirla a prendere.
Pensiamo ai festini agricoli, alle giovani donne che vanno ad abortire, a poi a questi bambini che vivono la realtà delle serre. Ci chiediamo cosa vedano tutti i giorni.
All’inizio non capivamo perché molte di queste donne rumene, a parità di paga (600 euro circa al mese), preferissero lavorare in queste campagne che presso le case degli italiani. Ivana e Adriana, come Liliana aveva fatto il giorno prima, ci confermano che una delle ragioni principali è certamente la famiglia. Chi presta cura a persone anziane è costretta a vivere da sola relegata con loro. Se si accetta di lavorare nelle serre, in cui peraltro c’è una richiesta continua di manodopera, è possibile invece portare con sé il marito o i figli. Sono tante le donne romene sui 40-50 anni che vengono a lavorare gomito a gomito con il mariti e i figli adolescenti.
Ivana e Adriana, inoltre, erano contadine anche in Romania. Non è difficile immaginare le condizioni da cui hanno deciso di emigrare, se si pensa che hanno preferito condurre i loro figli in questo mondo di miseria e sfruttamento, pur di portarli via da lì:
“se sei abituato dalla Romania, qui non è tanto più pesante”, dice Adriana con un sorriso.
Ivana sembra ancora volerci parlare di qualcosa. Ma alla presenza ingombrante del marito di Adriana si aggiunge anche quella del datore di lavoro italiano di entrambe. L’uomo ci chiede con una certa insistenza cosa siamo andati a fare lì. Gli diciamo della nostra ricerca sulle madri rumene. Non se ne va più. Pressa le donne perché tornino al lavoro. E le donne ci baciano, guardano gli uomini che le circondano, poi volgono ancora lo sguardo verso di noi e lo piantano nei nostri occhi: “sono niente”, sembrano dirci mentre vanno via. Qualunque cosa possano farci, loro sono niente.
Un ringraziamento particolare va a Paola Ottaviano, che nonostante il suo coraggioso e continuativo impegno da avvocata a fianco degli attivisti del movimento No Muos ha generosamente messo a disposizione il suo tempo e i suoi contatti per aiutarci a costruire questa inchiesta.
Note
[1] Le interviste di Adriana e Ivana sono state utilizzate anche in Sciurba, A., Doppiamente assenti per prestare “cura”.Donne migranti nel mercato del lavoro familiare in Italia in Grasso M., (a cura di) Razzismi, discriminazioni confinamenti, Ediesse, Roma 2013 (in corso di stampa)
http://www.meltingpot.org/Due-volte-sfruttate-Le-donne-rumene-nella-fascia.html#.UidoKn8WE_M