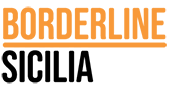L’abito della detenzione dei migranti tunisini
I cittadini tunisini sono la maggioranza dei migranti che vengono detenuti e rimpatriati. Sono sistematicamente criminalizzati e sottoposti a lesioni di diritti. Le storie e i corpi di Sami, Wissem, Akram e Bilel ce lo raccontano.
I migranti di origine tunisina sono coloro che più vivono sulla loro pelle gli effetti del razzismo istituzionale e della crescente militarizzazione della frontiera del Mediterraneo. In particolare, a partire dall’estate 2020 – a seguito dell’aumento degli arrivi sulle coste siciliane di cittadini tunisini – l’Italia ha messo a punto una efficientissima macchina per i respingimenti. Con l’intesa tra i due Stati, l’Italia si è impegnata a finanziare 8 milioni di euro per la rimessa in efficienza di sei motovedette in possesso della Guardia costiera tunisina in cambio dell’impegno della Tunisia nel rafforzamento dei controlli delle frontiere e dell’addestramento di forze di sicurezza che sorveglino le coste. Inoltre, è stato concordato il ripristino dei voli di rimpatrio dei tunisini – sospesi durante i primi mesi della pandemia – con quote settimanali prestabilite di cittadini da espellere attraverso 2 voli charter (arrivati fino a 3) a settimana. Sulla base di questa intesa sono dunque aumentati i provvedimenti di espulsione a carico dei tunisini, che tra novembre 2020 e gennaio 2021 hanno costituito l’80,5% dei cittadini stranieri transitati per i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) e il 75,5% dei cittadini stranieri rimpatriati dall’Italia, secondo i dati diffusi da ASGI.
L’instabilità economico-sociale e la crisi politica sono fattori che stanno spingendo migliaia di cittadini e cittadine tunisine – uomini, donne e numerosi MSNA – a lasciare il loro paese di origine: secondo l’UNHCR, nel corso del 2021, i migranti tunisini che hanno raggiunto le coste siciliane sono stati circa 15.671, la maggioranza sul totale degli arrivi. Ma a causa di questi accordi, soltanto una minima parte di queste persone ha avuto accesso alla possibilità di richiedere protezione internazionale: considerati a priori “migranti economici” e valutando come criterio soltanto quello della nazionalità, i tunisini entrano quasi automaticamente nelle procedure di espulsione e rimpatrio – in violazione della Convenzione di Ginevra – andando incontro a violenze di vario tipo.
Detenzione e rimpatrio: la macchina perfetta
Da quanto osservato, le procedure per il rimpatrio forzato dei cittadini tunisini in tempi di pandemia si realizzano in 3 passaggi:
Hotspot. Normalmente i migranti tunisini approdano sulle coste di Lampedusa o di Pantelleria. Per quanto riguarda Lampedusa, i migranti vengono portati all’hotspot di Contrada Imbriacola dove viene effettuata una procedura di pre-identificazione, nella quale avviene la compilazione del foglio notizie, il fotosegnalamento, la rilevazione delle impronte digitali. Da quanto osservato, le autorità di pubblica sicurezza applicano una selezione sostanzialmente automatica in base al Paese di provenienza dell’individuo e non viene fornita una corretta informativa legale. Infatti, i cittadini tunisini vengono esclusi quasi a priori dalla protezione internazionale e possono essere rimpatriati attraverso una procedura accelerata. Per i migranti giunti a Pantelleria, la procedura di pre-identificazione sembrerebbe svolgersi al centro di prima accoglienza di Pantelleria e l’identificazione viene completata nel CPR di Trapani Milo, nella cui struttura ci sono gli uffici della Questura.
Nave quarantena. Dall’identificazione si passa al confinamento in nave quarantena per il periodo di isolamento previsto per la prevenzione dal contagio da Covid-19. Da quanto osservato, più che un dispositivo sanitario, la nave quarantena risulta essere l’anticamera del rimpatrio dove completare la fase di incanalamento giuridico propria della procedura hotspot: il tempo di permanenza in nave serve a portare a compimento la selezione dei cittadini stranieri, distinguendo tra “richiedenti asilo” e “migranti economici”, tra chi accede all’accoglienza e chi viene espulso, ai fini di determinare i percorsi giuridici e semplificare le procedure di rimpatrio.
Allontanamento – espulsione. Dopo lo sbarco dalle naviquarantena, i migranti riempiono un secondo foglio notizie e qui si completa l’iter che porta all’espulsione dei tunisini. Questa procedura viene eseguita ancora una volta senza avere accesso alle informazioni, senza aver modo di raccontare la storia personale, senza permettere alle persone di manifestare la domanda di protezione internazionale, senza la possibilità di esplicitare altre situazioni che impedirebbero il rimpatrio (ricongiungimento familiare o altro). I cittadini stranieri irregolari che non possono soggiornare nel territorio italiano sono soggetti a un provvedimento di allontanamento dal territorio: ciò può comportare il trattenimento dei migranti nei CPR oppure viene emesso un ordine di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni. Con l’identificazione da parte dell’autorità consolare tunisina all’aeroporto di Palermo, viene permessa l’esecuzione definitiva del rimpatrio del cittadino tunisino.
Così, in queste poche fasi un migrante tunisino viene rispedito nel suo paese di origine senza nessuna garanzia a tutela dei diritti. Anche la possibilità di impugnare un provvedimento di allontanamento davanti ad un giudice non è sempre efficace: spesso il ricorso non ha effetto sulla sospensione dell’esecuzione del rimpatrio e il diritto alla difesa è ostacolato ulteriormente una volta che il migrante si trova confinato nel CPR. Inoltre, negli ultimi mesi la procedura ha subito una forte accelerazione e il rimpatrio può avvenire nei giorni successivi all’arrivo in centro. Le restrizioni legate al Covid-19, l’accesso limitato al CPR ad avvocati, ONG, mondo esterno e il sequestro dei telefoni cellulari dei detenuti impediscono ulteriormente l’esercizio effettivo dei diritti e quasi sempre i cittadini tunisini vengono rimpatriati senza aver avuto un colloquio con un legale. Tuttavia, tutto ciò non ha ostacolato la creazione di forme di comunicazione informale tra i detenuti e le reti di supporto legale, attraverso l’impegno di familiari e di associazioni – su tutti il Progetto In Limine e la Campagna LasciateCIEntrare – grazie alle quali molti migranti sono stati liberati dalla detenzione illegittima.
Infatti, l’esperienza di alienazione e privazione della libertà che i migranti devono subire è inseparabile dalle lotte per il riconoscimento dei loro diritti. Le forme di ribellione e di protesta, dall’hotspot alla nave quarantena fino al CPR si sono moltiplicate. Dalle pratiche di autolesionismo, agli appelli lanciati sui social, alle manifestazioni, i migranti, in particolare i tunisini, fanno del loro corpo – detenuto, umiliato e maltrattato – un campo di lotta.
Sami, Wissem, Bilel
Tra le numerose storie c’è quella di Sami, uomo tunisino detenuto negli ultimi due mesi nel CPR di Trapani-Milo, uno dei due CPR che si trovano in Sicilia, insieme a quello di Pian Del Lago a Caltanissetta. Nel corso del tempo in cui ha vissuto in reclusione nella struttura di detenzione siciliana, Sami si è ripetutamente autolesionato, procurandosi delle cuciture alle palpebre, alle labbra e sui genitali. Sami è stato trattenuto per ben due mesi e più volte sottoposto a ricoveri psichiatrici nel corso delle settimane, da ultimo quello avvenuto qualche giorno prima del presidio del 12 marzo 2022 indetto da varie realtà antirazziste davanti al CPR. Proprio in quell’occasione è stato possibile portare alla luce questa storia. Il suo caso non è isolato: è solo uno di quelli emersi dalla zona d’ombra che cela le prassi attuate in luoghi come i CPR, dove i migranti irregolarizzati sono sottoposti a detenzione amministrativa e alla privazione della libertà personale pur non avendo commesso alcun crimine.
Dopo le minacce di impiccarsi se non fosse stata predisposta la sua liberazione, il 14 marzo, con l’emissione di un decreto di non proroga del trattenimento, Sami è uscito finalmente dal CPR, libero di raggiungere la sua famiglia in Europa.
Non ha avuto la stessa sorte Wissem Ben Abdel Latif, giovane 26enne tunisino di Kebili, morto nel novembre 2021 in contenzione psichiatrica all’ospedale San Camillo di Roma, sedato e legato mani e piedi ad un letto di ospedale, dopo essere passato per il CPR di Ponte Galeria, dove è stato trattenuto nonostante il giudice di pace avesse sospeso il provvedimento di trattenimento. Per quanto abbia fatto di tutto per uscire da quella prigionia, Wissem ha trovato la morte nelle mani delle istituzioni. Una morte che non può essere archiviata e per questo è nato il Comitato Verità e Giustizia per Wissem Abdel Latif promosso dalla famiglia del giovane, dalla Campagna LasciateCIEntrare, dalla Fondazione Franca e Franco Basaglia e dall’Associazione Sergio Piro.
Una morte violenta anche quella di Bilel Ben Masoud, 20enne tunisino di Sfax morto mentre era recluso sulla nave quarantena Moby Zaza, a largo di Porto Empedocle, nel maggio 2020 durante l’isolamento sanitario. Bilel voleva la libertà ed ha tentato di attraversare il mare per raggiungere le coste siciliane. È stata la prima – e non ultima – persona a perdere la vita durante il trattenimento in una nave quarantena, un’altra delle infrastrutture che lo Stato ha disposto per confinare le persone migranti, privarle della loro libertà personale e di fatto facilitare la loro espulsione.

Il CPR di Trapani Milo – Foto di Silvia Di Meo
Corpi che resistono
Dunque l’invisibilizzazione e l’abbandono alla sofferenza e alla morte delle persone migranti – propria delle necropolitiche migratorie – non impediscono pratiche di resistenza attraverso l’incorporazione della violenza da parte di quegli stessi corpi reclusi. Lo dimostrano anche le numerose storie dei migranti in detenzione di cui hanno raccontato Francesca Esposito, Emilio Caja e Giacomo Mattiello nel volume da loro curato “Corpi reclusi in attesa di espulsione. La detenzione amministrativa in Europa al tempo della sindemia”: alle violenze contro i migranti, i corpi resistono, anche quando le loro storie vogliono essere rimosse.
Tra i corpi le cui storie vogliono essere cancellate c’è quello di Akram Taamallah: tunisino di Menzel Bourguiba, morto in un naufragio nel novembre del 2019, seppellito nel cimitero di Cefalù. Una “vita di scarto”, a cui è stata negata l’esistenza e a cui non è nemmeno concesso il lutto: un corpo tra molti di cui né lo stato tunisino né tanto meno quello italiano vogliono farsi carico per riportarlo in Tunisia tra i suoi cari. Il caso di Akram mostra il trattamento che destiniamo alle persone migranti, alle esistenze che consideriamo sacrificabili, non solo da vive, ma anche da morte: se da vivi i migranti sono corpi su cui si esercita dominio e oppressione, fagocitati dalla macchina del contenimento e del respingimento, da deceduti non hanno più valore e in questi casi il rimpatrio – che comporterebbe il riconoscimento delle responsabilità politiche- diventa un carico individuale delle famiglie verso cui lo Stato si mostra indifferente. Tuttavia, quei corpi continuano ad essere corpi politici che reclamano e rivendicano giustizia, attraverso le voci di altre persone, i familiari e gli attivisti. Così, le cuciture sul corpo di Sami, i segni dei lacci della contenzione di Wissem e i resti di Akram seppelliti in Sicilia, resistono alla rimozione storica di quella violenza.
Non solo: in tempi di guerra dove domina la doppia morale che determina la gerarchia delle vite, questi corpi sono la testimonianza emblematica del razzismo selettivo del confine europeo applicato a chi esercita il diritto di fuga, che classifica chi è “meritevole” di accoglienza e chi non ha diritto alla libertà di movimento, che individua le vite “degne” di essere protette e quelle da lasciar morire senza alcun lutto.
L’abito della detenzione e tutti gli altri abiti
Durante l’evento di presentazione del Comitato Verità e Giustizia per Wissem Ben Abdel Latif , Yasmine Accardo, della Campagna LasciateCIEntrare, ha detto: “A Wissem è stato imposto l’abito della detenzione dall’inizio alla fine”. Infatti, dall’arrivo in hotspot alla nave quarantena al CPR al reparto psichiatrico fino alla morte, Wissem ha indossato sempre gli stessi vestiti: gli è stato impedito di cambiarsi, è stato abbandonato alla disumanizzazione e all’abbrutimento fino alla morte.
Quello della detenzione è il vestito che lo Stato cuce addosso alle persone migranti criminalizzate in partenza: non solo su Wissem, ma su tutte le persone che vivono lo stesso trattamento discriminatorio. I tunisini sopra tutti, definiti “migranti economici”, gli irregolari per eccellenza, i “criminali”, quelli che non hanno diritto, a cui è imposto sistematicamente il ritorno forzato, la reclusione, l’umiliazione, la violenza.
Ascoltando le parole di Yasmine e visualizzando mentalmente “l’abito della detenzione” di cui parlava, mi sono immediatamente venuti in mente altri abiti di Wissem che avevo visto a Kebili, città natale del giovane, dove sua madre Henda e sua sorella Rania mi hanno ospitato quando le ho visitate nel dicembre 2021. Nel giorno della mia visita, nella stanza di Wissem – dopo lunghi discorsi sulla detenzione e sulla sofferenza – le due donne avevano tirato fuori dall’armadio e impilato davanti ai miei occhi i suoi indumenti: vestiti per lo sport, per uscire con gli amici, per lavorare, cappelli, scarpe. Quell’esibizione aveva lo scopo di mostrare la vita materiale di Wissem, in tutte le sue sfaccettature, come a dire: tutto questo era Wissem, non lo dimentichiamo. Il corpo selezionato e scartato, rivestito dall’abito della prigionia e della contenzione, è un corpo che ha lottato per la sua libertà. Il portafoglio sul tavolino, il letto rifatto, i racconti delle sue sorelle: questo era Wissem, non un migrante da espellere, ma un giovane uomo che aveva progetti, la cui vita è ancora lì che pulsa tra quelle mura.
Oggi Rania e Henda lottano nel Comitato Verità e Giustizia per Wissem Ben Abdel Latif, con le associazioni, gli avvocati ma anche con tutte le altre madri e sorelle tunisine che ricercano i figli scomparsi o morti nel Mediterraneo, a cui la violenza della frontiera ha inferto le stesse ferite, più o meno letali.
Con le altre donne tunisine, Henda e Rania ricamano lenzuoli con il volto e la storia di Wissem e di tutti gli altri che hanno portato “l’abito della detenzione”: giovani bloccati in mare prima di arrivare, giovani che sono naufragati, che sono stati rimpatriati, che si sono autolesionati, che forse alla fine sono fuggiti dalle navi quarantena e dai CPR, portando con loro i segni indelebili di quella lotta.
Tutti i vestiti, le foto e i lenzuoli ricamati di nomi e storie sono oggetti che abbiamo il dovere di esibire: sono i simboli che si oppongono all’ “abito della detenzione” che si vuole cucire addosso ai tunisini e ai migranti criminalizzati. Sono i segni di esistenze non riducibili a vite scartate ed espulse. Sono la memoria indelebile che ricorda: migrare non è un crimine. Umiliare, violentare e uccidere, sì.
Silvia Di Meo
Borderline Sicilia