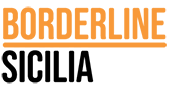Migranti: Catania, gli sbarchi, le persone e i numeri
di Valeria Brigida – IlFattoQuotidiano – La ragazza non si accorge che, nel trascinarsi dalla pancia della Bulwark al gazebo per l’identificazione, il suo piccolo che ha in braccio perde una scarpetta. Un operatore della Croce Rossa raccoglie la scarpetta, segue la ragazza e gliela restituisce. Lei gli sorride. E’ nel momento in cui allunga il braccio per prendere la scarpetta che vedo sul dorso della sua mano quel numero: 55. Osservo quella fila indiana che fuoriesce silenziosa dalla pancia della Bulwark. La numero 55 ha davanti a sé una ragazza che sul dorso della mano riporta il numero 54. Dietro a lei, un’altra ragazza, un’altra mano: numero 57.
Lo scorso lunedì, a Catania, assisto allo sbarco di oltre 1000 migranti dalla nave da guerra britannica Bulwark che, da poche settimane, il Regno Unito ha deciso di impiegare per sostenere le operazioni di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo. Tutti i “salvati” – donne e uomini più o meno giovani, minori non accompagnati, ma anche bambini di pochi mesi in braccio a mamme e papà – vengono fatti scendere sul molo, in fila. Hanno tutti un numero scritto col pennarello sul dorso della propria mano. Lo stesso numero compare su un pezzetto di nastro adesivo attaccato sulla spalla. Uno ad uno, vengono identificati: ciascuno deve prima accostare al volto un cartello con un altro numero per il foto segnalamento; quindi, rilasciare le impronte digitali; poi deve sedersi a terra sull’asfalto – col sole o con la pioggia – all’interno di un perimetro delimitato da transenne che non permettono alla stampa di avvicinarsi troppo; infine, dopo ore, deve salire sul pullman per esser “smistato” in uno dei centri di accoglienza sparsi in Italia.
Tutto questo avviene sotto lo sguardo di noi giornalisti e operatori dell’informazione. Siamo tanti, da tutto il mondo. E ci sono anche curiosi di ogni età, accorsi al porto per vedere la nave da guerra britannica che spicca tra una crociera e un mercantile.
Durante gli sbarchi diurni capita spesso di vedere questi curiosi che fanno foto col loro smartphone o con una macchinetta digitale compatta.
Stavolta per me la vera sorpresa sono quei numeri sul dorso delle mani dei migranti.
Chi ha segnato col pennarello quei numeri? Mi avvicino al comandante della Bulwark non appena finisce di rilasciare le interviste alla stampa. Pacatamente, chiedo spiegazioni. Perché di sbarchi ne ho visti un po’. Eppure è la prima volta che vedo la “pratica” dei numeri sulle mani. Il comandante mi risponde che si tratta di una misura “utile” che serve ai militari per non sbagliarsi nel conteggio delle persone. Non riesco a trattenere la seconda domanda: le persone salvate come hanno reagito a quel conteggio sulla propria pelle? Un breve silenzio del comandante. Forse non si aspettava quella domanda? Poi, sicuro, continua sostenendo che le persone sono felici per il solo fatto di essere state salvate, che a loro non importa nulla di quel numero sulla pelle. Si appunta il mio nome sul taccuino e se ne va.
Eppure quei numeri risvegliano qualcosa. Rievocano un passato neanche troppo lontano. Perché? Ho molte domande che si accavallavano nella mente. In termini di “identità”, cosa rappresenta un numero identificativo scritto sulla pelle? Cosa rappresenta in Europa “quel” numero identificativo scritto sulla pelle dei migranti in questo preciso momento storico? Un paio di settimane fa ho partecipato a un incontro in Senato dal titolo “Lezione morale. Il peccato dell’indifferenza. L’Europa, la Shoah, la strage nel Mediterraneo”. C’erano il presidente del Senato Pietro Grasso, il presidente della Commissione Diritti Umani del Senato Luigi Manconi, il giornalista Gad Lerner, il professore Alessandro Portelli e Piero Terracina, testimone della Shoah, unico sopravvissuto della sua famiglia alla deportazione ad Auschwitz.
Proprio a Catania, mentre assisto allo sbarco della Bulwark, mi tornano in mente le parole di Piero Terracina che paragona “la colpevole indifferenza della comunità internazionale” durante la Shoah alla “colpevole indifferenza di oggi”, durante un periodo caratterizzato dalle morti nel Mediterraneo. Osservo i numeri sul dorso delle mani dei migranti e mi chiedo: è giusto fare questo riferimento storico?
Lascio sedimentare queste domande per qualche giorno. Poi, decido di rivolgerle a chi potrebbe darmi una risposta.
Il professor Shaul Bassi, docente di letteratura e teoria postcoloniale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, mi spiega che “le analogie sono un modo importante di pensare, ma sono anche un’insidia. Ovviamente c’è una differenza tra lo scrivere numeri cancellabili sul corpo di persone che si vogliono salvare e il tatuare numeri indelebili su quello di persone che si vogliono sterminare. Il rischio dell’analogia è che si banalizzino le tragedie o si crei una specie di classifica/competizione delle tragedie che riduca le loro rispettive specificità”.
Il professor Bassi però si trova d’accordo sul tema dell’indifferenza: “E’ un fenomeno su cui riflettere attentamente, perché alcune persone sono facilmente dimenticabili e riducibili alla non identità. Forse, i corpi neri sono più ‘scrivibili’ di quelli bianchi, perché siamo abituati a rappresentarceli già come massa senza identità e senza nome, a vederli come collettività sofferente e non come soggetti portatori di singolarità. Il mare in cui muoiono è una zona di eccezione che ci consente di sbarazzarci di alcuni senza sentircene colpevoli. Purtroppo noi discriminiamo anche le vittime: di quelle protagoniste di truci delitti domestici, arriviamo ad analizzarne ogni minuto di vita per mesi; di alcuni, invece, non sappiamo nemmeno il nome. Io vorrei, ed è per questo che studio letteratura e apprezzo moltissimo il lavoro di scrittori come Igiaba Scego, che ricostruissimo il più possibile delle vite singolari di queste persone. Che dal numero risalissimo a delle storie. Sempre, per forza, poche nel mare delle persone, ma capaci di ricordare agli indifferenti che lì ci sono vere esistenze, distrutte in un momento”.