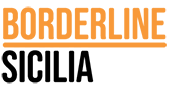Parla che non ti ascolto: il racconto della solitudine nei CAS
Quando arriviamo a Menfi presso il CAS “Gianturco” della cooperativa
Quadrifoglio, incrociamo i Carabinieri nel cortile. Succede spesso, così ci
avevano già avvertito gli operatori, che gli ospiti (al momento 12) richiedano
l’intervento di Carabinieri e Polizia.
La situazione nella piccola struttura è tesa. Salutiamo, ma a malapena
riceviamo una risposta. Ci vogliono parecchi minuti per attirare l’attenzione
su di noi e radunarli nel salotto con l’aiuto degli operatori.
“Noi
conosciamo i nostri diritti, e sappiamo anche che non vengono rispettati. Per
questo parliamo con i Carabinieri e la Polizia, perché loro sono quelli che
dovrebbero proteggerci, no? Ma o ci dicono di avere pazienza, o che non possono
risolvere i nostri problemi, oppure non ci ascoltano nemmeno. Ieri siamo stati
dai Carabinieri, abbiamo parlato con il Commissario, lui ci conosce, sa la
nostra storia, lui stesso ha detto di rivolgersi a lui per qualsiasi cosa. Ha
detto che sarebbe passato stamattina qui al centro per parlare con noi, e
invece è arrivato un suo sottoposto. Non è la stessa cosa, lui non ci conosce e
ci ritroviamo a ripetere le cose mille volte senza mai raggiungere qualcosa di
concreto”. Sbarcati a P. Empedocle nel novembre 2014, da 9 mesi questi
ragazzi, prevalentemente originari dell’Africa occidentale francofona,
aspettano la data di audizione in Commissione.
All’inizio, erano pazienti. Avevano un buon rapporto con gli operatori, c’era
un clima di fiducia, di collaborazione. “E’ stato così fino a quando
loro [ndr, gli operatori] hanno smesso di garantirci i nostri diritti, dicendo
che non potevano aiutarci a risolvere i nostri problemi”. Raccontano, si
interrompono, discutono tra di loro, ricominciano a raccontare. “Settimana
scorsa siamo andati ad Agrigento a ritirare i permessi di soggiorno rinnovati.
Dovevamo firmare per ritirarli, ma all’inizio ci siamo rifiutati, volevamo
prima sapere quando ci sarebbe stata la Commissione per noi. Ci hanno detto di
fare come volevamo, se non firmavamo non potevamo ritirare il documento.
Abbiamo cercato di parlare con i poliziotti, spiegare la nostra situazione, la
nostra disperazione. Non ci hanno voluto ascoltare, allora ci siamo seduti
nell’atrio ad aspettare di essere ascoltati da qualcuno. Ci hanno detto che non
potevamo restare lì, che dovevamo uscire. Noi volevamo solo parlare, volevamo
solo qualcuno che ci ascoltasse, ma ad un certo punto ci hanno buttato fuori
con la forza. Alcuni di noi sono caduti a terra, li hanno tirati su e li hanno
buttati fuori. Cosa vogliono dire quelle uniformi se poi veniamo trattati così?”
Poi chiedono conferma se c’è una Commissione ad Agrigento e se ha già iniziato
a lavorare. “Lì in questura un poliziotto ha detto che ad Agrigento non c’è
nessuna Commissione, che si fa tutto a Trapani. A chi dobbiamo credere ora? Lui
è uno con l’uniforma, perché dovrebbe dire una bugia?”. Il peso delle
parole dette da uomini in divisa non è affatto da sottovalutare. Che siano
dette per ignoranza, per disinteresse, per leggerezza o con l’intenzione di
placare tensioni: queste frasi sono pure bombe a orologeria e nella maggior
parte dei casi è appurato che aggravano drasticamente la situazione psicologica
dei migranti nonché la relazione, già incrinata, tra quest’ultimi e i loro
operatori, i quali, a loro volta, vengono etichettati come coloro che “non
riescono a prendersi cura di noi”, che dicono bugie, che non sanno fare il
loro lavoro.
Da ciò che raccontano, diviene chiaro come inconsciamente i ragazzi
sappiano che la colpa della loro frustrazione, della loro attesa, della loro
disperazione è del sistema mal funzionante e malsano italiano, di cui parte
attiva sono le stesse autorità. Quando glielo facciamo notare, annuiscono. Ma
le parole “sistema” e “autorità” sono parole vuote, astratte. I ragazzi hanno
bisogno di una persona reale con cui interfacciarsi, con cui dialogare. Il che,
a livello pratico, quotidiano, è l’operatore, che, ritenuto altrettanto
responsabile e colpevole per la situazione di sospensione in cui si ritrovano,
diventa inevitabilmente il capro espiatorio, il magnete della loro rabbia.
Pensano che un trasferimento possa giovare alla loro situazione in qualche
modo, sebbene alcuni dicono che amano stare a Menfi e vorrebbero rimanere.
D’altronde, la popolazione non pare essere disposta ad entrare troppo in
contatto con loro, la disperazione è al limite della sopportazione, come anche
la loro rabbia. “C’è un motivo se siamo scappati dai nostri paesi. Se
andasse tutto bene, noi saremmo rimasti. Abbiamo fatto un viaggio terribile,
che nessuno di voialtri può anche solo immaginare. Siamo arrivati qui pensando
di avere protezione e diritti. Ma è meglio morire con dignità che vivere in
questa situazione”. La maggior parte dei ragazzi vuole ricevere un
trasferimento oppure andarsene. Dicono di avere già avvisato le autorità che
succederà, così nel momento dell’esodo, nessuno potrà dirsene sorpreso.
Proviamo a spiegare loro che il trasferimento potrebbe essere un terzo trauma
per loro, dopo quello di dover lasciare il proprio paese e quello di aver già
aspettato 9 mesi per una data. Inoltre, non è detto che da altre parti la
situazione sia meglio e più veloce, anzi. C’è il rischio che debbano
ricominciare l’iter da zero, allungando ancora di più la loro attesa. Ma loro
sono convinti, non vogliono restare, sono stanchi, arrabbiati, desolati. Sono
determinati, nei loro occhi c’è una luce che fiammeggia. Sono vivi e vogliono
vivere, ormai non hanno più niente da perdere. Ringraziano per essere andati lì
a trovarli, per averli ascoltati, per avere capito le loro ragioni: “Più di
così non potete fare, lo sappiamo. Grazie lo stesso”.
La stessa benedizione non viene concessa agli operatori del centro però,
che subiscono e riportano forti tensioni durante lo svolgimento del loro
lavoro. Saluti mancati, risposte brusche, minacce orali (“vado dai carabinieri
e ti metto nei guai”), sfiducia, frustrazione. “Ci sentiamo lasciati da soli
dalle autorità”, dice una responsabile, “ma anche dalle organizzazioni
umanitarie, che partono sempre dal presupposto che i migranti siano le vittime
e gli enti gestori i carnefici”. Il “male” di gestori e utenti è comune: il
sistema, con tutti gli attori che ne fanno parte. Eppure, coloro che si
scannano alla fine sono i primi due. Il risultato? Poca affluenza ai corsi di
italiano, astensione alle attività organizzate dall’ente gestore (come per
esempio il boicottaggio della festa per la fine del Ramadan), rifiuto di
dialogo, atteggiamenti sprezzanti, litigi, silenzi. La goccia che ha fatto
traboccare il vaso è stato il “sequestro” degli operatori nel secondo centro
Quadrifoglio a Menfi, il CAS “Sant’Antonio”. L’esasperazione dei
ragazzi li ha portati a ricatti, azioni di sabotaggio (come il blocco delle
auto degli operatori in modo che non potessero allontanarsi dalla struttura) e
giusto ieri il sequestro degli stessi operatori per 5 ore in una stanza. Evento
che ha portato la responsabile a richiedere al Prefetto la chiusura definitiva
di entrambi i CAS. “Ci dispiace di essere arrivati a dover chiedere la
chiusura dei centri, ma noi non ce la facciamo più. La situazione ormai è
ingestibile e a volte abbiamo paura di andare a lavoro”. Un’operatrice dice
di sentirsi umiliata dai ragazzi, che spesso non le rivolgono la parola se non
per dirle di pulire il bagno o raccogliere la spazzatura che gli ospiti hanno
deliberatamente buttato in cortile invece che negli appositi bidoni come tacita
forma di ribellione.
Una situazione andata fuori controllo, proprio in due centri che,
abitativamente e logisticamente, funzionavano nel complesso bene. Improntati
più come residenza permanente che come centro emergenziale, le due strutture
(spartane, ma in buono stato) ospitano al momento rispettivamente 12 e 17
ragazzi, seguiti da uno staff di circa 7 persone. Un mediatore è disponibile
specialmente al momento dei collocamenti e dell’informativa legale, la
psicologa a chiamata, e ogni 10 giorni si
tiene una riunione con operatori ed ospiti per fare il punto della situazione,
con la partecipazione di un interprete, mentre lo stesso staff rimane
raggiungibile telefonicamente anche di notte. L’erogazione del pocket-money di
2,50Euro/8 giorni è sempre stato regolare, come anche la distribuzione di
vestiti, acqua minerale in bottiglia, kit igienici, ecc. (su firma dei
beneficiari in ogni occasione, “sia a tutela degli utenti, che nostra degli
operatori”). Inoltre, agli inizi di maggio sono stati obbligati dalla
Prefettura ad accogliere due nuclei famigliari composti da una donna incinta e
una coppia, con la moglie in stato di gravidanza altrettanto avanzato. Sbarcati
a Lampedusa il 2 maggio, dopo il trasferimento a P. Empedocle, le due famiglie
sono ospitate presso il CAS Sant’Antonio, in una piccola
casetta adiacente l’edificio principale per rispettare sia per veitare la promiscuità
che per garantire un minimo di privacy alle famiglie. A fine maggio, nel giro
di una settimana, le due donne hanno partorito uno bimbo e una coppia di
gemelli nell’ospedale di Sciacca. In quel momento non essendo ancora in
possesso del permesso di soggiorno, i genitori non hanno potuto registrare i
neonati all’anagrafe, né garantire loro l’assistenza del pediatra del SSN. Fortunatamente
i bimbi sono stati seguiti a titolo gratuito dalla pediatra di fiducia di due
operatrici. Da qualche giorno sono finalmente arrivati i permessi di soggiorno
consentendo ai genitori di registrare i figlioletti. Ma i due nuclei familiari
vivono ancora in un CAS. La responsabile denuncia di avere richiesto in diverse
occasioni a prefettura, questura e Servizio Centrale il trasferimento in
strutture più idonee ed adeguate nell’ambito del sistema Sprar. Eppure, dopo 3
mesi, ancora nessuna reazione. E di questi giorni la notizia che il Servizio Centrale abbia trovato
posto per il nucleo famigliare con i due gemelli, che dovrebbero essere
trasferiti la prossima settimana. Per l’altra madre con neonato, invece, non è
stato ancora trovato un alloggio adeguato.
Caterina Botticelli
Borderline Sicilia Onlus