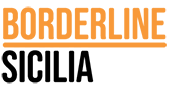Centro di prima accoglienza per minori a Giarre: parlano i ragazzi
Giarre, comune alle pendici dell’Etna di circa 27.000 abitanti, ha ospitato negli ultimi anni diverse comunità per minori non accompagnati. Progetti di cui abbiamo avuto modo di denunciare le criticità, chiusi in seguito all’intervento dei Servizi Sociali per poi essere riaperti dagli stessi gestori altrove, obbedendo a logiche di potere e di business che si rivelano decisamente difficili da estirpare.
 |
| Il centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, a Giarre (CT) |
Nel gennaio 2016, la Cooperativa “San Giovanni Battista” ha preso in gestione un centro di prima accoglienza per msna (minori stranieri non accompagnati), ubicato nei pressi del Parco “Chico Mendez”, una zona distante alcuni chilometri dal centro storico di Giarre ma discretamente collegato con i principali servizi della cittadina. La struttura dovrebbe rientrare tra quelle istituite ai sensi del DPRS n. 600 del 2014, che prevede una capienza di 60 persone ed una permanenza di massimo tre mesi, con degli standard di accoglienza molto precisi da rispettare.
Nel giugno del 2016 veniamo contattati da un gruppo di ospiti della struttura e da alcuni volontari della vicina parrocchia che ci chiedono supporto per una situazione di “difficile gestione”. Ci diamo appuntamento al parco ed iniziamo quindi ad ascoltare i racconti dei primi mesi che questi ragazzi hanno trascorso in Italia cercando di individuare le questioni che hanno trasformato in vero e proprio stato d’allarme la loro iniziale preoccupazione. “Ora siamo circa 80 ma nei primi mesi c’erano anche 100 persone”, (a fronte della capienza massima di 50). La struttura è molto ampia, dormiamo in camere da due o tre letti, ci sono spazi comuni, tv , un tavolo da tennis ed il wi-fi. Quando arrivi però non hai soldi e quindi non puoi chiamare casa magari anche per settimane. Gli operatori ci dicono di chiedere in prestito il cellulare ai nostri compagni e noi spendiamo i nostri pocket money per comprarci a rate dei telefoni e poterli poi ricaricare.” Parte del pocket money viene speso pure per comprare nuovi vestiti, visto che ai minori viene garantito solo un cambio di vestiario, e soprattutto per rifornirsi di cibo, in sostituzione di quello dato dal centro che dicono essere “scarso e di pessima qualità”. Da alcune foto che ci mostrano possiamo notare le dimensioni ridotte delle porzioni.
Ciò che inquieta i ragazzi è però ben altro. Innanzitutto la questione dei documenti: le uniche informazioni avute sulla procedura che li attende sono state date dal team di Save the Children in sede di sbarco, poi solo silenzio o la stessa risposta dagli operatori: “Bisogna aspettare”. Lo stesso vale per l’assegnazione del tutore: la maggior parte dei presenti è arrivata cinque o quattro mesi fa, ma solo in pochissimi hanno avuto la fortuna di averne assegnato uno. Questi dicono che a volte lo sentono ma hanno dialoghi brevi e difficoltosi per via della lingua e “il tutore ripete sempre che è necessario avere pazienza ed aspettare”, senza spiegare bene che cosa. I ragazzi si sentono abbandonati e confusi durante le visite mediche, le analisi e i prelievi del sangue che li spaventano molto perché nessuno spiega loro di cosa si tratta. Il tutore è sempre assente, anche nei casi sanitari più gravi e di ricovero ospedaliero. Alcuni ospiti riferiscono di essere stati molto male e nonostante ciò l’unica soluzione adottata dagli “amministratori”, (termine usato da tutti per indicare gli operatori del centro), è stata il ricorrere al pronto soccorso, dopo lunghi periodi di indifferenza. Ci viene mostrato un video girato mentre un ragazzo viene portato via urlante dall’ambulanza e ci raccontano la storia di un giovanissimo ragazzo eritreo, di circa 13 anni, completamente solo e spaesato, impossibilitato a trovare chi capisse la sua lingua e giunto al centro in condizioni di salute già critiche. “Faticava a salire le scale per raggiungere la sua camera da letto, sputava sangue ed era sempre stremato”; un giorno è stato disposto il suo ricovero in ospedale, durato alcune settimane. Al suo ritorno, il ragazzo sembrava essersi lievemente ripreso ma dopo alcuni giorni si è allontanato spontaneamente e “da solo” dal centro. Di lui più nessuna notizia così come delle decine di ragazzi che ci dicono allontanarsi frequentemente da soli poche settimane o pochi giorni dopo l’arrivo. Tra di loro, molti somali ed eritrei, che spesso hanno anche meno di 15 anni.
Anche le lezioni di italiano sembrano un miraggio e vengono reclamate a viva voce dai presenti, andati fino in parrocchia a chiedere un sostegno: “Ci avevano detto che dal mese di luglio saremmo stati iscritti ad un corso, cosa che non è avvenuta. Ora facciamo al parco due lezioni a settimana, ma non tutti.” Il gruppetto di ragazzi con cui parliamo ha scritto diverse lettere consegnate agli “amministratori” ed al responsabile della struttura, “perché visto che non ci ascoltavano abbiamo pensato almeno di farci leggere e reclamare i nostri diritti”. Chiedono di avere un tutore, dei corsi di italiano, la possibilità di inserirsi sul territorio e di visitare facilmente la moschea di Catania. Una di queste lettere è stata consegnata alla Procura presso il Tribunale dei Minori di Catania da un volontario e 4 ragazzi hanno poi formalizzato l’esposto recandosi presso gli uffici alcuni giorni dopo: “Abbiamo dato i nostri dati e firmato un foglio ma non sappiamo dire altro, speriamo.”
Facciamo le segnalazioni del caso e rimaniamo in contatto con i ragazzi, che ci chiedono di non parlare per il momento con gli “amministratori” del centro perché siamo stati visti insieme a loro e temono ripercussioni. Sappiamo che alla fine del mese di giugno 2016 alcune persone della Procura catanese hanno fatto una visita al centro, intrattenendosi con i gestori. La situazione rimane comunque invariata per settimane, mentre molti degli ospiti raggiungono la maggiore età senza aver ancora potuto formalizzare la richiesta di documenti.
Intanto nuovi ospiti continuano ad arrivare ed altri ad allontanarsi durante i mesi autunnali. Alcuni però restano, anche dopo aver compiuto 18 anni e ricevuto un documento, in un luogo di primissima accoglienza dove la permanenza prevista dovrebbe essere massimo di tre mesi. Al centro non mancano proteste da parte dei ragazzi, spesso sedate chiamando la polizia o i carabinieri; la qualità del cibo sembra migliorare, e in molti frequentano la “scuola” nel pomeriggio.
Ritorniamo a Giarre ai primi di marzo, poco più di un mese fa, per chiedere ai gestori di visitare la struttura. Nell’occasione incontriamo anche parte del team di Terres des Hommes, presente all’interno del centro ogni giovedì con il Progetto Faro, per dare supporto psicologico e proporre attività socio educative tra cui l’insegnamento della lingua italiana. Veniamo accolti all’ingresso da un’operatrice, che ci ferma suggerendoci di formalizzare la nostra richiesta via email e soprattutto ci conferma l’imminente trasferimento di alcuni ragazzi neomaggiorenni al Cara di Mineo. Sono decine i casi del genere ed anche alcuni dei ragazzi che conosciamo ed incontriamo poco dopo all’esterno, sono tra quelli costretti a subire l’ennesima prassi illegittima implementata dalla Prefettura e non ostacolata né denunciata in alcun modo dal centro. “Da quando entriamo speriamo di essere trasferiti in uno Sprar, poi da un giorno all’altro ci dicono che andremo a Mineo”, ci confida M.. Per lui, ad un passo dalla licenza media, sarà davvero difficile diplomarsi quest’anno. Due, tre, quattro settimane di e-mail e chiamate di sollecito per avere un segnale dai gestori: all’ennesima telefonata, la coordinatrice del centro ci comunica che la nostra visita “per ora non si può fare”, rifiutandosi di motivare il perché e chiudendo frettolosamente la conversazione.
Impossibilitati ad avere un dialogo con i gestori, continuiamo a monitorare la situazione dall’esterno e a segnalare le criticità riscontrate a chi di dovere. In questo momento la struttura ospita circa 50 ragazzi, dei quali più della metà neomaggiorenni, prevalentemente originari di Nigeria, Mali, Senegal, Costa d’Avorio ma anche Ghana ed Eritrea. L’età media si aggira sui 16/17 anni, da mesi non si registrano nuovi arrivi e gli allontanamenti “spontanei” hanno interessato trasversalmente tutte le nazionalità: “Noi rimaniamo perché non abbiamo parenti o contatti all’estero”, ci dicevano i ragazzi un anno fa, ma questa frase risuona ancora molto attuale.
M. ci dice: “Da almeno un mese non andiamo a lezione: la scuola è lontana, il pulmino è rotto e non ci possono accompagnare. Nel mese di marzo non è stato dato nemmeno il pocket money, abbiamo chiesto di parlare con il responsabile per capire il motivo ma la coordinatrice ostacola ogni nostro incontro con lui. A volte chi va a chiederle spiegazioni esce dal suo ufficio con del tabacco, anche se minore, o qualche euro, ma nessuna notizia”. Diversi ragazzi sono già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma dopo un anno passato qui non sono ancora stati trasferiti: “Se volete siete liberi di andarvene in qualsiasi momento”, è la risposta che sembra andare per la maggiore a chi sollecita un trasferimento o chiede informazioni sul proprio futuro. R., titolare di un permesso per motivi umanitari, vorrebbe richiedere il passaporto, ma l’unica indicazione che ha avuto è stata quella di andare ad informarsi direttamente a Roma presso l’ambasciata del suo paese, senza alcun sostegno per le spese del viaggio, per il costo della pratica e nessun tipo di supporto per l’espletamento della procedura. La giustificazione di gestire un centro “emergenziale” è inaccettabile quando la posta in gioco è il futuro di un ragazzo e si assiste addirittura alla mancata tutela dei diritti di base: “Ci fanno prelievi e controlli ma se stiamo male ci danno solo OKI. Se uno è al limite c’è il pronto soccorso, ma te lo devi proprio guadagnare”. Diversi ragazzi, anche se arrivati da un anno o quasi, non risultano ancora in possesso del codice fiscale e della tessera sanitaria. Alcuni lamentano di avere difficoltà di concentrazione, ansia, incubi e preoccupazioni ricorrenti, perché la speranza di costruirsi un futuro si sgretola ogni giorno di più a confronto con la realtà dei fatti. L. ci dice: “Molti di noi lavorano nei campi, per circa 20/25 euro al giorno e tanta rabbia. Alcuni hanno faticato per settimane, senza ricevere un euro alla fine, ma se si vuole guadagnare qui non ci sono molte alternative”. Nessun aiuto per introdursi nel mondo del lavoro legale, compilare un curriculum, avere contatti con associazioni in grado di fornire un supporto; triste e logica conseguenza di chi d’altronde non garantisce ai ragazzi nemmeno il possesso dei documenti più importanti.
“Tra tutti solo il traduttore è stato disposto ad aiutarmi per il codice fiscale. Spero di averlo presto, per iniziare a cercare lavoro e potermene finalmente andare”, dice R. Dopo sei mesi in Libia ed un anno in Italia, molti sono nella sua stessa situazione, vittime della violenza di un sistema respingente e delle prassi di mala gestione che le Prefetture continuano a tollerare e l’opinione pubblica si ostina a definire di “accoglienza”.
Lucia Borghi
Borderline Sicilia Onlus