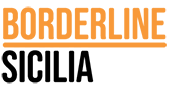Una vita di frontiera – A Lampedusa dopo più di un mese dal naufragio del 3 ottobre
Nicola Grigion, Meltingpot – Ad un mese e mezzo dalla drammatica notte del 3 ottobre scorso siamo tornati a Lampedusa per raccontare la realtà dell’ultimo lembo di terra a Sud dell’Europa proprio quando sull’isola si sono spenti i riflettori dei media e la vita torna ad essere quella di sempre, alle prese con doppi turni nelle scuole, senza un’ospedale dove poter partorire, con la benzina più cara d’Europa, sospesa nell’incertezza di chi vive una vita il cui destino è deciso altrove.
Sull’aereo che parte da Palermo c’è con noi Giusi Nicolini, il Sindaco che ha portato la voce degli isolani fino Bruxelless. Gli altri passeggeri sono in gran parte volontari che una volta usciti dall’aeroporto andranno a gonfiare le fila di grandi e piccole associazioni che hanno costruito progetti a Lampedusa.Noi alloggiamo davanti ad un’immensa struttura blu che si trova all’interno dello scalo aereo: è l’hangar in cui per molti, troppi giorni, sono state custodite le bare delle vittime del naufragio. Da lì iniziamo a muoverci verso il porto. Quando si apre di fronte a noi il vento inizia a soffiare forte. Il mare è molto mosso e rende impossibile imbarcarsi, così, per il momento, gli arrivi si sono diradati facendo calare il sipario sullo spettacolo del confine. L’impressione però è che questa sia solo una tregua concessa all’isola, in attesa che riprenda lo scontro tra le spinte di chi fugge dalla miserie e la potente macchina che vorrebbe ingabbiarle: un copione divenuto ormai la quotidianità di Lampedusa.Ci avviciniamo al molo dove erano allineati i corpi restituiti dal mare lo scorso 3 ottobre. Ora è vuoto. Le onde sono altissime e lo sovrastano. Quando si ritirano, dopo essersi infrante sul cemento della banchina, sembrano volersi portare via i segni della tragica notte in cui hanno inghiottito tutte quelle vite umane. Anche la politica, come il mare, è capace di cancellare in un istante le tracce delle sue brutalità, ma non fa altrettanto l’isola. A fatica ricomincia la routine quotidiana. Le attività commerciali vanno via via chiudendo, l’estate è lontana ed il vento di tramontana anticipa l’inverno. Il ricordo di quei tragici giorni non è però sbiadito. Piuttosto Lampedusa sembra aver ammortizzato il colpo come solo chi ne ha incassati tanti nella sua storia riesce a fare. Uno dopo l’altro, almeno tanti quante sono le carrette accatastate al cimitero del mare che non riesce più a contenerle.Gli abitanti popolano le strade per qualche ora al giorno. La presenza più massiccia è invece quella militare. Ad ogni angolo delle strade ci sono mezzi della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, uomini dell’Aeronautica, della Marina, dell’Esercito e della Croce Rossa. Non manca nessuno. L’occupazione di Lampedusa non è però ostentata. Sembra piuttosto di vivere all’interno di un’enorme caserma. Un grande carrozzone che ruota intorno al presidio del confine e che a queste latitudini non fa più clamore. Una normalità che non riesce però a far vivere una vita più tranquilla agli abitanti.Domenica notte al porto sono approdate circa sessanta persone, quasi tutte di nazionalità nigeriana. Intanto la flotta di Mare Nostrum, l’operazione messa in campo dal governo in risposta alla tragedia del 3 ottobre, pattuglia il Canale di Sicilia. Ma nonostante gli arrivi dei migranti si siano diradati, l’ultimo natante soccorso, così come quelli che hanno eluso i controlli della Marina nelle scorse settimane, testimonia l’assoluta impotenza dei pattugliamenti di fronte all’infernale circuito dei viaggi della speranza a cui è costretto chi fugge dalla guerra per la mancanza di alternative di ingresso regolare e sicuro. E’ la stessa Giusi Nicolini a sottolineare la fragilità della risposta targata Mare Nostrum. L’abbiamo incontrata in Municipio dove una lunga fila di lampedusani la attendeva. Lei riceve tutti. Il giorno prima, a S.Giovanni Michele Boscagli, ritirava un premio che potrebbe tradursi in un nuovo ecografo per l’e donne dell’isola, oggi invece discute l’itinerario del pullman che porta al poliambulatorio, di una iniziativa per incentivare la raccolta differenziata, di delibere ed atti degli anni precedenti da annullare. Il filo diretto con Roma e Bruxelless non si interrompe ma al tempo stesso gli isolani la reclamano per risolvere tutti quei piccoli grandi problemi ereditati dalle amministrazioni passate. “Gli sbarchi si sono temporaneamente diradati – ci dice – ma è evidente che il problema sta a monte e va ricercato nelle politiche europee e nel modo in cui l’Europa intende gestire le sue frontiere”. Lo stesso vale per le condizioni in cui vengono accolti i richiedenti asilo. “Ora il centro, che versa in condizioni indegne, è stato quasi totalmente svuotato e questo è un un ottimo risultato, ma se non ci si attrezza per gestire questa questione di chi fugge dalle guerre in maniera diversa, il problema si ripresenterà allo stesso modo una volta che gli sbarchi riprenderanno.Proprio il CPSA è stato al centro di un’accesa polemica nei giorni successivi al 3 ottobre, quando le persone confinate al suo interno erano centinaia. Dormivano in sistemazioni di fortuna all’aperto, in molti senza letto, i servizi igienici erano in condizioni deplorevoli. Tra loro c’erano molti minori. Poco dopo il nostro arrivo abbiamo incontrato alcuni operatori di un’organizzazione internazionale presente sull’isola che ci hanno descritto il quadro della situazione. Nel centro ora di minori non ce ne sono più. Sono stati tutti trasferiti dopo la denuncia di Save The Children. In molti hanno già fatto perdere le loro tracce. “Durante quest’ultimo mese – dicono gli operatori – abbiamo lavorato in una condizione veramente caotica”. Entrare ed uscire dalla struttura è un’operazione complessa, che richiede molto tempo per la consegna delle liste, ottenere le autorizzazioni e superare la trafila dei controlli. A questo va aggiunta l’incertezza che ha regnato in questo periodo sull’isola.La composizione delle persone arrivate in questo periodo li ha colpiti particolarmente. “C’erano molte famiglie siriane con figli altamente scolarizzati, persone distinte che in Siria occupavano posizioni di rilievo. Sono in fuga dalla guerra ma si sono portati dietro tutta la loro dignità. Erano addirittura disposti a pagarsi un albergo per alloggiare in un luogo degno, invece sono stati costretti a vivere in quelle condizioni a Contrada Imbriacola”. Nello stesso periodo sono arrivati moltissimi rifugiati dal Corno d’Africa, come gli eritrei sopravvissuti al naufragio. Tra i più giovani le strategie per superare il trauma vissuto sono le più disparate. “Scherzano tra loro ricordando quei momenti – ci racconta un operatore – anche questo è un modo per elaborare l’esperienza. Prendono in giro chi si è salvato solo grazie all’aiuto di un adulto, oppure chi è arrivato sul molo senza pantaloni perché in acqua, qualcuno, poco più sotto di lui, glieli ha strappati nel tentativo di non affogare”.Il centro cerca di celare queste storie. Ora le presenze lì dentro sono decisamente calate e non non vanno oltre le centocinquanta persone. Alcuni saranno trasferiti a breve. La tensione intanto è stata scaricata sulla Sicilia, dove vengono allestiti continuamente nuovi centri informali che riscrivono la cartografia del confinamento. A Contrada Imbriacola non sono però cambiate le condizioni della struttura. Ai cancelli un presidio dell’Aviazione e dell’Esercito ha l’ordine di gestire gli ingressi e le uscite, mentre Polizia e Carabinieri controllano l’interno. A rendere più semplice il loro lavoro ci pensa però il varco, ormai pluriennale, ricavato nella rete che si trova sul retro, da cui i migranti entrano ed escono senza distrarre i militari ai cancelli da tablet e smartphone. Una vera e propria valvola di decompressione. Così i ragazzi eritrei passeggiano a drappelli per le vie del paese in attesa del tanto sperato trasferimento sulla terra ferma. Li abbiamo incontrati davanti alla sede dell’Archivio Storico di Lampedusa, un’associazione culturale che ha ricostruito la memoria dell’isola attraverso un decennale lavoro di recupero di immagini e materiali. Sullo schermo posizionato in vetrina va in onda un film in lingua eritrea scaricato appositamente per loro. La panchina davanti alla sede è diventata il salotto dove trascorrono qualche ora fuori dalle mura del centro di accoglienza. Nino Taranto, fondatore dell’associazione, ci spiega che, dopo aver visto i migranti fermarsi spesso davanti alla tv, incuriositi dai documentari messi in onda, ha deciso di offrirgli qualche ora di distrazione. “La cultura è un mare che unisce”, ci tiene a sottolineare.Parliamo con i ragazzi. Non sono minori ma basta guardarli in faccia per capire che in pochi superano i vent’anni. Alcuni sono qui da poco, altri dall’inizio di novembre, in sedici invece vivono a Contrada Imbriacola dal 4 ottobre scorso. Sono i sopravvissuti del naufragio di cui ha parlato tutto il mondo. Anzi, di più, sono i testimoni chiave dell’inchiesta aperta sui fatti di quella notte dalla Procura di Agrigento. Tra loro c’è anche il ragazzo che ha riconosciuto gli scafisti, il somalo ed il palestinese che insieme ai militari libici si sono resi protagonisti degli stupri alle donne e delle violenze contro di loro. Non hanno molta voglia di parlare, ma quando capiscono perché siamo sull’isola rompono gli indugi. Yoseph (nome di fantasia) ci racconta il suo percorso verso l’Europa. Partito nel 2009 dall’Eritrea, ha vissuto e lavorato due anni in Etiopia dove a raccolto il denaro per proseguire il suo viaggio. In seguito si è trasferito nel Sud del Sudan dove ha trovato un impiego per un altro paio d’anni. Poi è venuto il momento di ripartire. La sua storia segue il copione delle tante altre che abbiamo sentito ripetutamente in questi anni. Quella delle violenze e delle brutalità subite nel circuito della compravendita di esseri umani che ancora caratterizza la Libia, nonostante la caduta di Gheddafi. Varcato il confine, i trafficanti a cui aveva pagato la bellezza di quattromila dollari, lo hanno venduto ai militari. Imprigionato nelle carceri libiche ha pagato ancora per essere rilasciato e consegnato ad un’altra organizzazione dedita alla tratta, che gli ha permesso di raggiungere Bengasi. Poi si è imbarcato. Ora, dopo aver lasciato molti amici sul fondo del mare ed essersi separato dagli altri ottantanove compagni di viaggio trasferiti a Roma, di cui si sono già perse le tracce, spera solo di lasciare Lampedusa. La sua nuova prigione. Ha testimoniato contro gli scafisti e si ritrova rinchiuso in condizioni disumane nel CPSA. Vuole lasciare l’isola ma le autorità hanno paura che varchi il confine Italiano per raggiungere altre mete, rendendo vana l’inchiesta. Ma non c’è davvero un altro modo per assicurarsi la sua testimonianza?A rendere probabile la sua fuga non è un’irragionevole attrazione per gli stati del Nord Europa, ma sono le condizioni indegne del sistema di accoglienza a cui l’Italia costringe i rifugiati. Per questo in molti sono disposti a pagare e rischiare ancora – dice – anche una volta calcato il suolo italiano, per rimettersi in viaggio.Prima di prendere l’aereo che ci riporterà indietro ritroviamo Giacomo Sferlazzo con cui abbiamo condiviso le nostre giornate. E’ il punto di riferimento di Askavusa, l’Associazione culturale che in questi anni non ha mai smesso di urlare al mondo intero la sofferenza di Lampedusa. Ci aveva chiesto di respirare l’aria che tira per le strade del centro, di entrare nei bar, di vivere la quotidianità di questo pezzo di terra più vicino all’Africa che all’Europa. Ci salutiamo dandoci appuntamento per gennaio quando da queste parti si ritroveranno i movimenti euromediterraneo per scrivere “la carta di Lampedusa” e dar vita ad una campagna contro le attuali politiche sull’immigrazione.Dopo averlo ascoltato a lungo ce ne andiamo con più certezze. In fondo rivendicare i diritti dei migranti che fuggono dalle persecuzioni non è cosa diversa da reclamare quelli degli abitanti di Lampedusa. Costretti a vivere da diverse angolazioni la precarietà della vita, ma accomunati da una sola grande necessità: cambiare la geometria dell’Europa, qualunque sia il colore della tua pelle.