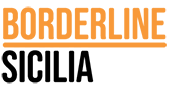Il dolore delle ferite invisibili
A più di quarant’anni dalla legge Basaglia, il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe interrogarsi su come ha recepito e messo in atto le tutele previste dalla legge. La presa in carico del disagio psichico è un aspetto fondamentale di ogni società, su cui si misura effettivamente la capacità di un sistema di welfare di garantire tutele ai più vulnerabili, italiani e stranieri.
E anche su questo versante, come in tanti altri, i migranti che giungono in Italia, mettono in luce le criticità del sistema sanitario che, se nella teoria si professa universale, nella pratica accentua discriminazioni ed esclusioni.
Le numerose associazioni presenti ed attive a Palermo lottano tutti i giorni per facilitare le pratiche burocratiche e permettere ai migranti non solo di ottenere un documento valido per risiedere sul territorio, ma soprattutto per aiutarli a trovare risposte immediate a bisogni urgenti come un pasto caldo al giorno e un luogo dove dormire o lavarsi. Quando agli sportelli si presentano o vengono intercettate persone con delle problematiche specifiche come nel caso di un disagio mentale, si cerca tempestivamente di inserire la persona in un percorso ad hoc che tenga conto dei bisogni e delle cure necessarie. Le persone individuate come “vulnerabili” o come portatrici di disagio psichico, però, trovano difficoltà maggiori, non solo ad essere inserite in un percorso di accoglienza adeguato, ma anche a ricucirsi un posto in “società”.
Se da un lato i posti in seconda accoglienza per persone migranti individuate come vulnerabili non sono sufficienti, dall’altro molte persone che necessitano di un percorso di cura e/o di riabilitazione non posseggono documenti e questo li esclude a priori dalla presa in carico. A queste difficoltà si aggiunge che un disagio mentale deve essere dimostrato e documentato, ma la mancanza di personale formato a riconoscere persone vittime di tortura o trattamenti inumani e degradanti, e in grado di riconoscere le ferite “invisibili”, rende ancora più difficile dimostrare formalmente i disagi che derivano da tali esperienze.
Per gli operatori e le operatrici (degli sportelli, delle comunità, delle associazioni) che si spendono per cercare delle soluzioni, cresce la frustrazione e lo stress, che nascono prima di tutto dall’incapacità di fronteggiare il dolore altrui e dalla mancanza di risposte concrete e adeguate in seno ai servizi di presa in carico. Per il migrante, è difficile non solo trovare uno spazio di espressione (lontano dai centri o dalle istituzioni), ma soprattutto essere ascoltato ed essere supportato in un processo attivo di cura o riabilitazione. Il disagio spesso viene letto come mera sintomatologia medico-psichiatrica e si cerca dunque di oggettivarlo.
Le risposte più comuni (forse perché anche le più rapide) sono la somministrazione di un farmaco che spesso non è accompagnato da un percorso riabilitativo. Hussein, ad esempio, è stato seguito da vari specialisti a Palermo, ma dormendo per strada e non avendo il permesso di soggiorno, le semplici medicine non servivano nemmeno ad attenuare il dolore che arrivava e si presentava regolarmente impedendogli di dormire e lavorare.
C’è un altro aspetto che non bisogna dimenticare, e che pure è molto spesso taciuto o sottovalutato. I lavori di Ernesto De Martino e dello stesso Franco Basaglia fanno emergere come la “malattia” debba essere letta in termini sociali e come essa possa rappresentare un momento di resistenza all’ordine costituito, un momento di indignazione nei confronti dell’ordine sociale da parte di quelli che ne sono tagliati fuori. Da qui nasce la necessità di creare ambienti terapeutici “neutrali”, che non rinviino alle gerarchie in cui si inserisce il disagio psichico, spazi in cui si possa ascoltare davvero la persona. Il migrante che ha un disagio psichico prova a comunicarci un disagio più grande, non solo legato al suo passato ma anche alle esperienze di discriminazione o rifiuto vissute in Italia.
L’attesa di arrivare a destinazione, riuscire ad ottenere dei documenti, trovare un posto sicuro dove vivere, cercare un lavoro, ritrovare i propri cari, sono solo alcune delle attese lunghe e costanti con cui i migranti devono fare i conti una volta in Italia.
Suleyman per anni è passato da centri di accoglienza a comunità sino alla strada, un percorso non lineare o razionale, ma sempre frutto di negoziazioni e sforzi per far garantire e riconoscere i propri diritti fondamentali. Come molti migranti approdati in Italia, Suleyman ha dovuto lottare non solo con i suoi fantasmi ma anche con la burocrazia lenta e discriminante. Dopo aver seguito i consigli, dato fiducia alle persone e lottato per i suoi diritti si è ritrovato con in mano un diniego o, in altri termini, di fronte all’ennesimo rifiuto da parte delle istituzioni, minacciando così di compiere un atto estremo: il suicidio.
Aveva investito tutte le sue energie in un percorso per vedersi riconoscere la protezione internazionale, quei documenti cartacei che gli avrebbero permesso di rifarsi una vita, di essere riconosciuto“degno” dalla nostra società. Tutte quelle energie gli sembravano vane, solo il suicidio gli pareva percorribile, ultimo modo possibile di rendersi testimone di quella violenza insita nel non riconoscimento di sé che molti migranti vivono. Il termine arabo per testimone e martire è lo stesso, shahīd: come se la morte fosse di per sé una testimonianza. È forse questo il termine giusto per descrivere l’atto di Suleyman.
Queste attese sono spesso logoranti. Le risposte a volte estreme dei migranti vanno lette alla luce di un sistema di accoglienza complesso, che spinge ai margini, certo, ma anche ai limiti individuali, mettendo alla prova gli spazi più intimi dell’“Altro” che respingiamo. Storie come quelle di Suleyman, seppure spesso meno eclatanti, non sono rare, e le risposte non sono solo gesti di disperazione, ma atti di resistenza da leggere in relazione alle condizioni di esistenza e alle forme di esclusione e subordinazione sociale che molti migranti subiscono. I medici degli ambulatori, gli operatori dei centri di accoglienza, ma anche gli operatori delle molte associazioni presenti a Palermo, dopo numerose visite ed incontri con i migranti riscontrano spesso la perdita di sonno, li vedono contorcersi per dolori lancinanti allo stomaco, o ancora sono testimoni dei loro passaggi da momenti di totale passività ad altri di rabbia furiosa. Questi stati d’animo, e fisici, sono inspiegabili con il solo sapere medico e la soluzione non può e non deve essere solo un farmaco o peggio un TSO.
L’inefficacia terapeutica del sistema medico deriva proprio dal fatto che esso concentra la sua attenzione prevalentemente sul disturbo, sul sintomo, tralasciando il significato rivestito dall’esperienza del soggetto che ne è afflitto. Se a questo si aggiunge il carattere emergenziale dei servizi per migranti presenti sul territorio e la scarsità di tempo e di risorse da destinare ad interventi riguardanti la salute mentale dei migranti, il panorama si aggrava e si rende ostile alla persona con disagio psichico. Il disagio o malattia psichica dovrebbe essere ripensata come una delle tante forme attraverso le quali si manifesta la sofferenza sociale. Riprendendo le parole di Arthur Kleinman, Veena Das e Margaret Lock, “per sofferenza sociale s’intende la risultante di ciò che il potere politico, economico e istituzionale fanno alla gente e, reciprocamente, di come tali forme di potere possono esse stesse influenzare le risposte ai problemi sociali”.
D’altro canto, e a ben vedere, la malattia si presenta ad un tempo come il più individuale e il più sociale degli eventi. Ogni sapere deve essere messo alla prova del sociale e ogni intervento e decisione da parte degli operatori dovrebbe tenerne conto.
Sofia Agosta
Borderline Sicilia