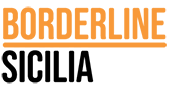Perché continuare a morire
Poco più di cento euro e qualche settimana di attesa. Queste sono le modalità ed il prezzo da pagare per ogni cittadino italiano che vuole avere un passaporto. Chissà in quanti, chiedendo o usando i propri documenti, sono consapevoli che per migliaia di persone un’operazione ormai banale e di routine, non è mai stata e non è ancora possibile. Chissà se i cittadini europei pensano almeno un istante che per avere la stessa libertà di circolazione ci sono persone ancora oggi costrette a pagare con la propria vita, a consumarsi in prigione per mesi e a vendere il proprio corpo.
Chi vive in Paesi massacrati dalla guerra non può fuggire liberamente. Chi nasce in Stati derubati dalle proprie risorse materiali, economiche ed umane e strozzati dalle nostre politiche neoliberiste, non può spostarsi alla ricerca di una vita migliore come capita a noi, o meglio, non lo può fare in un modo libero e sicuro. Così si parte dalla Siria, dall’Afghanistan, dal Pakistan, dallo Yemen, dal Corno d’Africa e dai paesi subsahariani, cercando di raggiungere l’Europa, paladina dei diritti umani e obbligata dalle sue stesse leggi a fornire protezione ed asilo. Si attraversano paesi, continenti, deserti, ci si affida a trafficanti senza scrupoli che diventano l’unica possibilità di salvezza, si arriva in Libia e si prende il mare, dove finisce per sempre il viaggio di molti.
Le morti continue di questi giorni vengono riprese dai media in modo impreciso e come fossero semplici bollettini di una guerra che non ci appartiene, invece che stragi che stiamo attivamente collaborando a provocare. Ora non sono più solo i vivi a non fare “notizia” ma anche i morti, che aumentano di giorno in giorno in maniera esponenziale, con più di 3800 persone decedute in mare da inizio anno e che sono destinate solo ad aumentare, in mancanza di canali umanitari e sicuri.
Nel frattempo l’Europa e l’Italia stanno a guardare, cercando di contenere con altre deportazioni e prassi illegittime le conseguenze drammatiche del totale fallimento dell’approccio hotspot e delle pratiche di relocation, sorvolando ancora sull’assurdità del Regolamento Dublino ed aspettando l’occasione migliore per aumentare i controlli e la militarizzazione delle navi nel Canale di Sicilia.
“La barca su cui siamo partiti era piccola e sembrava rompersi da un momento all’altro. Eravamo solo in 27 ma anche così non ci muovevamo. Ci hanno detto che per noi non valeva nemmeno la pena spendere i soldi per una bussola, tanto erano sicuri che saremmo stati soccorsi subito. O perlomeno lo speravano per noi, ma senza troppa convinzione”. L. è arrivato da pochi giorni in Sicilia e vive con altre circa 500 persone ancora all’hotspot di Pozzallo, dove il sovraffollamento ed i tempi prolungati di permanenza sono ormai routine e diverse persone sono costrette a dormire nelle tende allestite all’esterno dell’hangar. “So che sono stato molto fortunato perché sono vivo ma sono anche molto molto arrabbiato perché ho capito che anche qui non sarà facile avere una vita come gli italiani. Ho viaggiato per un anno, sono stato sei mesi in carcere in Libia e ancora dovrò continuare a morire un po’ tutti i giorni, fino a quando forse non avrò un documento. Alla fine, io non sarei mai scappato ma ho dovuto farlo.”
Mentre in Italia ci si adopera per rendere più efficace la collaborazione in materia di rimpatri con la Nigeria e si cerca di far passare sotto silenzio gli accordi presi con il Sudan, giungono nei porti siciliani anche molte ragazze nigeriane, spesso minorenni, inserite in reti di traffico e tratta legate alla prostituzione o a forte rischio di esserlo una volta arrivate. Molte di loro, in mancanza di centri idonei e soprattutto di un’adeguata attenzione per il loro stato di vulnerabilità, si sono ritrovate in comunità sprovviste del personale adatto o in centri improvvisati aperti con affidamento diretto delle Prefetture, come nel caso della provincia di Ragusa. Luoghi che spesso diventano riferimenti più agevoli per chi le vuole sfruttare piuttosto che ambienti “protetti”. “In Nigeria l’unico modo per non morire di fame è la prostituzione. Questo mi ha detto mia mamma”. A parlare è J, una ragazza 16enne di Benin City che incontriamo in una struttura protetta nel catanese: “Io sono la minore di tre figli e mia mamma ha preso accordi per me. Così avrei avuto soldi per mantenere tutti, ed è iniziato il mio viaggio senza che io capissi bene dove fossi diretta. Ho viaggiato giorni chiusa in un auto con altre persone che non conoscevo e mi sono ritrovata in Libia, dove tutto è diventato molto più chiaro”. “Da quando sono partita da Abuja ho incontrato solo trafficanti, polizia o sfruttatori. Qui sarà diverso ma per me non è facile avere fiducia in chi ha in mano un’arma o in chi vuole sapere tutto di me senza dirmi perché”, dice un’altra ragazza ospite dello stesso appartamento. In questi casi, come in molti altri, è fondamentale l’assistenza individuale ed effettuata da personale competente già fin dall’arrivo, e di certo l’essere ammassati in mezzo a centinaia di altre persone in un hotspot o in una tendopoli al porto non lo rende possibile. D’altronde le finalità dell’approccio hotspot sono l’identificazione, il controllo e la selezione dei migranti, e quelle delle forze di polizia l’individuazione dei “presunti scafisti”; la tutela dei soggetti vulnerabili non ha sicuramente una priorità nelle prassi concrete della cosiddetta “accoglienza”.
Così è anche per le centinaia di minori non accompagnati, partiti per diventare la fonte di reddito di intere famiglie o per scappare da servizi di leva che si trasformano in chiamata perenne alle armi: “Una delle strategie più usate dalle ragazze come me, per evitare il servizio militare, è di avere una gravidanza.” – dice C, che ha 15 anni ed è fuggita dall’Eritrea – “Spesso però neanche questo ci salva, perché dobbiamo scappare dalla nostra stessa famiglia, e quindi tanto vale mettersi in viaggio e basta”. Come lei, sono decine i giovani eritrei che cercano una salvezza in Europa e per farlo sono costretti ad affidarsi a reti di sfruttatori senza scrupoli, che non esitano ad abusare di loro anche una volta giunti in Italia. Qui dovrebbe essere loro garantita la possibilità di avere informazioni comprensibili sui rischi che possono correre e sui diritti che gli sarebbero garantiti nel nostro paese; una procedura che richiede tempo oltre alla giusta attenzione e competenza, ma che in Italia non ha ancora lo spazio necessario, in un sistema organizzato intorno alla “emergenza” e alla visibilità. Ed è così che in molti fuggono non appena arrivati, percorrendo a piedi chilometri o allontanandosi da comunità/parcheggio per prendere il primo autobus diretto al nord.
Sono molte altre le storie che ascoltiamo da chi approda in Italia, dopo la tappa obbligata in Libia, nelle carceri e nei campi di detenzione di cui, non dimentichiamoci, anche l’Italia ha finanziato la costruzione una decina di anni fa. Arrivano sempre più spesso dopo aver perso un parente, un amico, quasi tutta la speranza ma non la dignità. Tra di loro anche diversi siriani, passati dall’inferno delle bombe a quello delle traversate in mare, e cittadini yemeniti, in fuga da un paese dove sono ripresi i bombardamenti in cui si usano anche armi italiane.
Per comprendere meglio come mai tanta gente continua a morire, prima di giungere in Italia ed anche dopo esservi arrivato, basterebbe davvero poco; a volte solo la capacità di ascoltare chi ci passa accanto o condivide gli stessi spazi nelle città che abitiamo, piuttosto che farselo raccontare da chi strumentalizza storie e sofferenze altrui per propri interessi politici o elettorali. Ma questo significherebbe anche chiederci perché questo continua a succedere e non si vogliono trovare soluzioni alternative.
Lucia Borghi
Borderline Sicilia Onlus