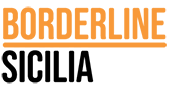Per non restare in silenzio
Pozzallo, Augusta, Catania, Lampedusa, Palermo: in Sicilia continuano gli arrivi via mare dalla Libia. Al largo delle coste si susseguono soccorsi, naufragi e morte. Migranti morti nei camion frigo che li trasportavano come merce, quali sono diventati, dalle regioni desertiche fino alla costa libica, da dove probabilmente avrebbero tentato la traversata verso l’Italia. Quelli ritrovati e menzionati dalla cronaca una settimana fa sono solo una minima percentuale delle migliaia che vengono trafficati ogni giorno, e che giunti in Italia cercano di spiegarci l’orrore che hanno visto, rimanendo troppo spesso inascoltati.

L’arrivo della nave Golfo Azzurro al porto di Pozzallo
I racconti di chi sopravvive sono chiari e dettagliati ma in pochi sembrano tenerne conto. La Libia è il paese con cui l’Unione europea sta gettando le basi per un’intesa volta a contrastare le partenze dei migranti attraverso il sostegno alla guardia costiera libica, che intanto si trova a raccogliere altri morti in mare, quando non sono le onde stesse a riportare i cadaveri direttamente sulle coste. L’Italia ha invece già stipulato accordi con le autorità libiche per combattere i trafficanti di esseri umani e ridurre gli arrivi, un atto riconosciuto per ora solo dal governo di Tripoli e di dubbia applicazione, che rimane però tanto ipocrita quanto allarmante.
E mentre si accavallano commenti retorici e ci si consuma in discussioni che raramente fanno emergere i veri interessi degli attori istituzionali, rimane assordante il silenzio di chi è costretto ad affrontare la morte quotidianamente e non parla, a volte per scelta, troppo spesso per costrizione.
Domenica 19 febbraio è giunta al porto di Pozzallo la nave Golfo Azzurro: a bordo c’erano 466 migranti stipati all’inverosimile, tra cui più di un centinaio di minori soli, diverse donne e famiglie, provenienti da Pakistan, Bangladesh, Africa Sub-Sahariana e pure dalla Siria, recuperati direttamente al largo della Libia in uno dei tanti interventi effettuati in quei giorni. Condizioni meteo critiche, trasbordi e salvataggi che hanno visto coinvolte anche le navi della Guardia Costiera e la norvegese Siem Pilot, inserita nelle operazioni di controllo e pattugliamento di Frontex. Le operazioni di sbarco a Pozzallo si sono susseguite secondo l’ormai noto copione, per cui le indagini e le procedure di controllo diventano le attività preponderanti in banchina, dove subito vengono separati dagli altri una dozzina di testimoni e i primi tre “presunti scafisti”.
Il sole cocente d’estate, la pioggia o il vento forte come in questa occasione, non hanno mai rallentato le operazioni investigative, anche se i migranti a stento sono coperti e se ciò a volte comporta lunghe attese per donne, famiglie e minori. Selezioni, fermi e trasferimenti effettuati senza le garanzie di traduzioni appropriate, che saranno poi alla base dei procedimenti penali avviati a carico di profughi sempre più spesso poi rilasciati e abbandonati fuori dal carcere dopo pochi giorni.
Il silenzio cala sulle ingannevoli promesse fatte ai testimoni per avere dei nomi, sul terrore che si legge negli occhi di chi viene additato dai compagni di viaggio e rimane con lo sguardo vuoto e fisso per ore, sull’inesistenza di una prima accoglienza degna di questo nome, che sia nell’unica stanza dell’hotspot di Pozzallo o nella tendopoli di Augusta o al Cara di Mineo. Ciò che risuona sono invece i nomi dei presunti scafisti fermati, la loro età, la loro provenienza; poco importa poi se molti saranno rilasciati, alcuni assolti, altri imprigionati senza poter nemmeno spiegare ciò che hanno subito prima di finire su un barcone, perché l’italiano non lo sanno ancora parlare.
Intanto proseguono le espulsioni, le fughe da centri emergenziali, la selezione dei migranti aventi diritto alla protezione sulla base della nazionalità. Tutte prassi illegittime che permeano il sistema della cosiddetta “accoglienza” e di cui sono testimoni non solo gli avvocati ma tutti gli attori istituzionali, i membri delle organizzazioni governative e non, gli operatori delle diverse strutture e tutti coloro che si interfacciano con i migranti forzati. Alcuni si scagliano contro le politiche europee, richiamando responsabilità che risuonano volutamente lontane, molti mantengono il silenzio su queste violazioni quotidiane, come se non fossero parte dello stesso sistema di violenza strutturale.
Avere voce e ascolto rimane invece un diritto da conquistare per la maggior parte dei profughi, approdati in un luogo dove questa possibilità viene garantita solo in alcuni casi. Parliamo di chi, facendo il proprio dovere e nonostante la fatica, promuove realmente le occasioni di inclusione sociale e socializzazione previste nei centri di accoglienza istituzionali ed alla base di una convivenza civile e solidarietà attiva. Conoscere l’italiano, entrare in contatto con la popolazione locale, acquisire consapevolezza e responsabilità rispetto alla propria situazione, sono le prime azioni che portano i migranti a non essere e sentirsi più numeri ma persone. A potersi autodeterminare e relazionare alla pari.
In molti altri casi però, ci troviamo dinanzi a situazione di marginalizzazione ed esclusione, sia fisica che sociale, nei confronti di chi arriva. Nei centri di accoglienza lontani dai centri abitati anche imparare l’italiano diventa un miraggio. Come nel caso di E., minore non accompagnato, che alloggia da quasi sei mesi nel centro di prima accoglienza gestito a Chiaramonte Gulfi, un paesino del ragusano. La sua struttura fa capo all’Opera Pia Rizza Rosso, già ente gestore di un CAS chiuso la scorsa estate ed ora ritornato ad avere in affido una ventina di minori. Qui le uniche lezioni di italiano sono quelle organizzate a giorni alterni nella struttura, e le settimane trascorrono tra partire di calcio “obbligatorie” e tanta solitudine e noia. Vivere isolati, non avere interazioni con altri coetanei italiani e non essere accompagnati all’interno della comunità di approdo porta frustrazione, rabbia, depressione, ma soprattutto voglia di fuga e non di progettazione.
“Se non sono scappato in questi anni è perché all’inizio ero troppo debole e senza soldi”, ci dice invece S., da febbraio 2015 “ospitato” in un CAS alla periferia di Vittoria(RG). “All’inizio era davvero difficile perché non capivo niente e più non capivo più i miei problemi aumentavano” continua, parlando ormai uno spedito italiano. S. viene dal Gambia e ci ha conosciuto nell’estate del 2015, quando ancora teneva lo sguardo inchiodato a terra mentre parlava e ci ripeteva ossessivamente di come per lui sarebbe stato impossibile imparare anche una parola di italiano perché durante le lezioni “la testa correva da un’altra parte”. Anche per lui è stato quasi impossibile frequentare la scuola: l’edificio dove si tengono le lezioni serali dista chilometri dalla struttura dove abita, in bici ci si impiega almeno mezz’ora e d’inverno il freddo ed il buio rendono il percorso davvero pericoloso.
Quindi niente scuola, niente nuovi amici ma solo lezioni sporadiche all’interno del CAS, che solo da pochi mesi è stato dotato di stufe ed impianto di riscaldamento, permettendo ai ragazzi di stare tranquillamente in soggiorno senza dover continuamente uscire o muoversi per riscaldarsi. Una situazione decisamente desolante che S. ha deciso di affrontare a muso duro, facendo leva soprattutto sulle sue risorse. “Mi sono accorto che potevo studiare da solo, con i libri che mi avevano dato. E ho iniziato a capire e soprattutto a potermi spiegare. Finalmente posso parlare con il mio avvocato, con chi incontro, dire quello che penso e sentire che la gente mi ascolta. Nel mio paese si mette la gente in prigione per non farla parlare; qui no, ma ho capito che ci sono altri modi per costringere al silenzio”.
Lucia Borghi
Borderline Sicilia Onlus